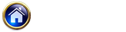Archivio
ricerca per autore
CAVA DE’ TIRRENI (SA). “Una famiglia quasi normale”: successo per la nuova performance comica di “Arcoscenico” E ora… se si aggiungesse qualche freccia all’Arco … scenico?
E ora … se si aggiungesse qualche freccia all’Arco … scenico?
In questi tempi di forzata interruzione ed in attesa delle due Pasque (quella religiosa di resurrezione e quella sperata del ritorno “fuori casa”), possiamo trovare il silenzio giusto non solo per la cronaca ma anche per una riflessione su questa seconda stagione di coprotagonismo dei giovani di Arcoscenico, compagni di viaggio della Chioccia Venditti e della sua storica compagnia del Piccolo Teatro al Borgo.
L’ultima prova, Una famiglia quasi normale (29 febbraio e 1 marzo, presso il Salone dell’Ex Seminario in Piazza Duomo a Cava de’ Tirreni) una storia farsesca di litigi familiari e tresche amorose consumatasi in una famiglia “allargata” con nonni e consuoceri, ha offerto varie conferme e nello stesso tempo induce a stimolare qualche necessaria “spintarella”.
In sé, è una delle migliori prove della serie comica di Arcoscenico, con fantasiose citazioni da teatròfili, un ritmo brillante che punta più all’equilibrio che al picco, una prova attoriale dell’intera compagnia che ogni volta conferma un significativo passo avanti. I tre big della “Trimurti” (Luigi Sinacori, capocomico autorregistattore, Gianluca Pisapia e Mariano Mastuccino) formano un ménage a tre affiatato e capace di bucare la scena, anche se (o perché…) si mantengono sui loro cliché preferiti.
In questo spettacolo Luigi e Gianluca sono due “neilsimoniani” vecchietti irresistibili, due consuoceri “anziani” (magia del teatro per due così giovani), in cozzo costante per diversità di caratteri e necessità di coabitazione. Luigi è nervosamente brontolone, ma tutto sommato interessato a fare andare avanti la barca, Gianluca è un vecchietto ancora con gli ormoni in giostra, quasi una maschera del vecchio “rattosello” di antico stampo atellano o plautino; vedovo in parte consolabile, è predisposto all’amore a pagamento e capace di amorose complicità col nipote, e tutto sommato un po’ “autofallico”, ma anche lui una persona ricca di umanità. In un ruolo non facile, anche per la necessaria deformazione della voce, Gianluca è riuscito a rendere il personaggio con adeguata vis comica unita ad una postura credibile ed agli abituali “gianlucheschi” stralunamenti. Mariano Mastuccino è il marito padre di famiglia che con la consueta moderazione attoriale cerca di trovare un equilibrio tra le intemperanze dei vecchietti, le beghe familiari classiche e le scenate della moglie (una vivace Francesca Cretella ben predisposta agli svenimenti), la quale non accetta le fughe d’amore del figlio (un misurato Federico Santucci), che per lei rimane un lattante di venticinque anni, mentre invece si imbosca con Enrica Auriemma, alias Liolà (chiara citazione dell’esplosivo “gigolo” pirandelliano), una ragazza carica d’amore ma prostituta per condizione sociale, una bella ragazza, piumata, sexeggiante proguadagno e dotata di un furbesco pianto “antiscopa”. Con loro, in una breve ma convincente apparizione, anche il serioso notaio Luca Ferrante e la quasi marchesineggiante segretaria Anna Cortone d’Amore.
Al di là della prestazione della compagnia, vorremmo però evidenziare, in rapporto a questo spettacolo, la simpatica, ben riuscita e fantasiosa contaminazione dell’intervento – citazione della pirandelliana Madama Pace, tenutaria di bordello dai pirandelliani Sei personaggi, qui napoletaneggiante anziché spagnoleggiante, che per convincere la ragazzina a non lasciare “il lavoro” le impone di inginocchiarsi, a mo’ del meroliano zappatore. La performance è stata affidata, con buon risultato, a Licia Castellano, un’attrice che, come la sempre brillante Pina Ronca, qui pettegola, invasiva e a volte devastante portinaia, assume nella compagnia un ruolo di caratterista, ma secondo noi entrambe potrebbero essere sperimentate anche in ruoli di maggiore respiro e profondità.
Questa considerazione ci fa aprire il discorso su una finestra riguardante proprio le conferme e le possibili prospettive legate al futuro dei nostri arcoscenici.
Innanzitutto, è confermata la capacità di Luigi Sinacori di scrivere storie brillanti e scoppiettanti, con un format quasi consolidato: microcosmi casalinghi in condomini con vasi comunicanti, tensioni personali e brontolii permanenti derivanti da piccole incompatibilità caratteriali intense ma non incomponibili, piccoli segreti e vizietti, intrighi economici ed amorosi, egoismi e trasgressioncelle alla fine perdonabili. L’intrusione del macrocosmo esterno in questo mondo “interno” ora fa venire a galla i problemucci ora funge da chiarificatore e da smantellatore dei pregiudizi. Tutto questo può essere sufficiente a creare uno spettacolo coinvolgente e gradevole, ed è quello che succede generalmente negli spettacoli targati Sinacori, quelli della serie “La gente vuole ridere”. Quell’ora e mezza trascorsa con le sue storie si beve con facilità e alla fine si applaude volentieri la compagnia e ci si ripromette di tornare a vederla.
Ma ora, evidenziati alcuni aspetti positivi, occorre dare la “spintarella”. Le storie che egli racconta, anche se mettono vagamente a nudo alcuni difetti dell’uomo e della società, risentono molto delle leggerezze tipiche della farsa d’altri tempi, in stile scarpettiano o in parte peppinodefilippiano, con personaggi e situazioni che appartengono più a quei tempi che ai nostri tempi. Del resto, anche Una famiglia quasi normale è ambientato, senza particolare sviluppo, negli anni ’70 del secolo scorso.
Salvando in gran parte questo stile autoriale, un salto di modernità in più non guasterebbe, soprattutto in uno scrittore così giovane. E parliamo dello stesso autore che nel bellissimo pur se “difficile” Hope dello scorso anno è stato capace di scrivere e recitare molto bene un testo dal sapore beckettiano, ai limiti dell’assurdo, ma con il respiro dell’universalità di una certa condizione umana.
E non dimentichiamo che in Arcoscenico c’è anche un altro autore, Mariano Mastuccino, che, anche lui in Hope e poi anche in Jude, ripetuto e rinnovato quest’anno, è stato in grado, scrivendo e recitando bene, di mordere situazioni scottanti come quella dei migranti o una storia sempre deflagrante come la Shoah.
Non diciamo questo per sollecitare la dedizione solo a spettacoli di qualità ma di nicchia, quanto per ricordare ai nostri cari “arcoscenici” che sono oramai maturi per arrivare a delle sintesi: spettacoli brillanti con più “persone” e meno “maschere”, con temi più attuali e approfonditi… e/ o spettacoli d’impegno con elementi di alleggerimento pesante e apertura di comunicazione. Della serie: La gente vuole ridere… ma con un po’ di zucchero non rifiuta di pensare…
Non limitiamoci però all’aspetto autoriale, ma apriamo una finestra su quello attoriale e, implicitamente, registico. Come stanno dimostrando con i progressi evidenti spettacolo dopo spettacolo, i tre della Trimurti Arcoscenica diventano sempre più affiatati tra loro e disinvolti sulla scena. Ci riescono più facilmente quando, usando una vecchia terminologia oggi forse disusabile, fanno gli “attori maschi” , cioè adattano i personaggi a se stessi o al proprio cliché più che se stessi ai personaggi. Secondo noi, potrebbero anche cimentarsi di più a fare gli “attori femmine”, cioè interpretare nel senso più completo personaggi costruiti da altri come l’autore li intendeva, ferme restando le proprie specificità recitative. Hanno già dimostrato in qualche momento di saperlo fare, come ad esempio nelle partecipazioni agli spettacoli di Venditti e in parte anche in Hope e Jude, lavori scritti da loro ma come se fossero un altro da sé. Una riprova ce l’avremo nel prossimo Il Sindaco del Rione Sanità (se ci sarà veramente il “grande ritorno”), ma ci piacerebbe anche vederli, che so, in un Pirandello brillante: per me, l’ideale sarebbe “L’uomo, la bestia e la virtù”. Questa costituirebbe anche una prova importante per Luigi Sinacori stesso per verificare i personali progressi e ambizioni di regia e trovare la famosa sintesi tra “cassetta” e “approfondimento”.
Non sappiamo quanto peso o verità possano avere tali osservazioni, ma noi riteniamo che quando si intravedono germogli e petali di una piantina ricca di humus e protesa verso una bella fioritura, allora una piccola aggiustatina ogni tanto non può che fare bene…
In fondo, si tratterebbe, per i nostri magnifici ragazzi in scena, di aggiungere solo qualche freccia all’Arcoscenico …
CAVA DE’ TIRRENI (SA). Ad un anno dalla scomparsa, ricordata a San Pietro Tina Masullo, “l’angelo della mano tesa”
 Ad un anno esatto dalla sua precoce scomparsa, avvenuta improvvisamente il 21 febbraio 2019 nella sua casa di Sant’Anna, sarà ricordata, alle 18,30, nell’amata Chiesa di San Pietro a Siepi la figura di Immacolata Masullo (per tutti Tina), una di quelle persone che nel silenzio e nella discrezione, ma con tanta sostanza, incidono nella vita e nell’immaginario di una comunità.
Ad un anno esatto dalla sua precoce scomparsa, avvenuta improvvisamente il 21 febbraio 2019 nella sua casa di Sant’Anna, sarà ricordata, alle 18,30, nell’amata Chiesa di San Pietro a Siepi la figura di Immacolata Masullo (per tutti Tina), una di quelle persone che nel silenzio e nella discrezione, ma con tanta sostanza, incidono nella vita e nell’immaginario di una comunità.
Oltre a dedicarsi con totale e amorevole cura alla sua numerosa famiglia (aveva sei figli: Biagio, Lucia, Alfonso, Riccardo, Francesco, Enza), insieme col marito, il popolare dottore veterinario Giuseppe Senatore, Tina donava il suo tempo libero alla vita della comunità parrocchiale dei Cappuccini e soprattutto alla vicinanza, morale e materiale, nei confronti degli altri, dei più bisognosi, offrendo un costante esempio di evangelica misericordia e calore umano. Oltre alle varie adozioni a distanza, lei e Giuseppe, avevano fatto della loro casa un “porto di mare” per l’accoglienza di persone di ogni età e nazionalità, come ad esempio i contaminati “profughi di Chernobyl”. Operava con slancio assoluto e una dedizione quasi spasmodica, con “durezza e bontà”, anteponendo le necessità altrui alle sue. Per questo, come hanno scritto i suoi cari nell’emozionante ed emozionata “pagellina” commemorativa, “era il sole alto e caldo nelle belle giornate di primavera… il valore delle piccole cose… una canzone cantata ad alta voce… la quotidiana scelta di dare il meglio… la compagna di tutti gli esseri viventi…”
Era proprio difficile non volerle bene e amarla con tutto il cuore.
Se ne è andata a soli cinquantacinque anni, per un malore improvviso, generando nei tantissimi che la conoscevano e le volevano bene un tragico sgomento ed un vuoto che svanga l’anima, ma anche lasciando una scia di esempio, di ricordi, di amore testimoniato e vissuto, che rimarrà nella memoria e nel cuore e produrrà un bene nuovo e rinnovato. Una scia ricca di profumo, il profumo di un fiore che non muore …
CAVA DE’ TIRRENI (SA). Il Sottovia veicolare dedicato a Guerino Amato, l’imprenditore che fece grande la Cavese
Alla presenza dei familiari e delle più alte autorità cittadine (Il Sindaco Vincenzo Servalli, il Vicesindaco Armando Lamberti, la Presidente del Consiglio Comunale Lorena Iuliano, l’Assessore Adolfo Salsano in primis), con la benedizione di Padre Rosario Sessa, sabato 1 febbraio è stato ufficialmente dedicato all’imprenditore Guerino Amato (Cava 1926-2009) il Sottovia veicolare. Dopo lo scoprimento della targa nell’uscita Nord, a Corso Principe Amedeo, una sobria e sentita commemorazione a Palazzo di Città… ed è cominciato il cammino nella memoria di un uomo che ha lasciato il segno in vari settori della Città e del territorio.
Formatosi come un vero self made man, intraprese il cammino industriale quando non aveva ancora compiuto trent’anni, nel 1954, dando vita all’omonima ditta Amato Guerino, poi rinominata in Beton Cave, specializzata in lavori di movimento terra e demolizioni. Riuscì presto ad acquistare un gran credito e, favorito anche dalla positiva contingenza economica, ebbe numerosissime commesse e si associò e collaborò con le più importanti aziende del periodo, Della Morte di Napoli, Penta di Roma, Zecchina Costruzioni di Napoli, risultando tra i protagonisti della realizzazione di un’opera epocale come l’autostrada Salerno-Reggio Calabria.
Forte del prestigio acquistato per una produzione di tale portata, lavorò anche presso Italsider, Bagnoli e Cementir Caserta, realizzò svariate demolizioni di vetuste fabbriche dell’Agro Nocerino Sarnese e contribuì alla costruzione di nuove aziende impegnate nella trasformazione del pomodoro.
La Beton Cave, collocata a Nocera Inferiore, fu la prima società in Campania per la produzione del calcestruzzo preconfezionato e l’estrazione di materiali di cava. Ebbe uno sviluppo tale da riuscire anche a moltiplicarsi, con la Beton Torre a Torre Annunziata, la Beton Campania a Pozzuoli e la Edil Riab a Contursi. Un successo che generò anche tanti posti di lavoro, toccando il picco di 250 dipendenti, e fu una linfa vitale per la città di Cava, perché la maggior parte di questi era cavese.
Le risorse economiche accumulate con questi lavori di grande qualità e prestigio gli permisero di dedicarsi anche ad attività collaterali, di notevole interesse pubblico.
Tra tutte, spicca la Presidenza della squadra di calcio (la Procavese, poi divenuta SS Cavese Calcio). Ancora oggi, per noi egli è l’uomo che fece grande la Cavese, in quegli anni ’80 che videro l’ascesa dalla serie D alla serie B nazionale, la storica “Real vittoria” contro il Milan con il team guidato dal carissimo Rino Santin, le sfide contro la Lazio (mai una sconfitta contro due storiche grandi del calcio nostrano), il traguardo della serie A sfiorato. Amato riuscì nell’impresa grazie ad una dirigenza capace, professionale, ad un’organizzazione efficiente e progettuale, ad una passione che triplicava le forze e i risultati..
Gli anni successivi a quel mitico 1982 della Real Cavese non furono invero molto luminosi e furono macchiati da diffuse ombre. Ci fu un decadimento della squadra, ma non del credito acquisito negli anni d’oro, che aveva portato il nome di Cava sotto tutti i riflettori nazionali.
Dallo sport alla musica: con la collaborazione del compianto Enrico Forte, vice comandante della polizia locale di Cava de’ Tirreni, Guerino Amato fondò un’importante casa di registrazione musicale, la RTO Record Tirrenia Olympia, che tra l’altro incise gli inni della squadra di calcio cittadina (al tempo, la Pro Cavese).
Egli utilizzò le sue risorse anche per significative operazioni nella vita sociale e religiosa. Fece tanta beneficenza nel silenzio della discrezione, ma produsse anche un’eclatante realtà ecclesiale: infatti, donando alla Parrocchia omonima guidata da Don Salvatore Polverino la costruzione della Grotta e tutte le opere annesse, si adoperò per la costruzione della Piccola Lourdes all’Annunziata di Cava de’ Tirreni, opera che ricopiava il più importante Santuario Mariano.
Non solo in questo esercitò il suo generoso spirito di solidarietà, ma anche in occasioni dolorose e importanti, come il terremoto dell’Irpinia e quello dell’Aquila, per cui mise a disposizione le proprie attrezzature per dare una mano alle popolazioni.
Nella vita familiare e nelle relazioni personali seppe guadagnarsi affetto e stima, grazie anche alla collaborazione della moglie Luisa, che diede calore alla casa e accoglienza ai tanti amici e conoscenti che frequentavano la loro casa di Piazza Vittorio Emanuele III.
Anche nella vita privata dovette affrontare situazioni difficili e delicate, che entrarono nelle cronache nazionali, ma riuscì sempre a superarle ed affrontarle con grande dignità, per cui alla fine risultava sempre vincente la sua immagine popolare di persona forte e umana e di generoso punto di riferimento per tutta una collettività. Insomma, seppe fino alla fine rimanere un “cemento Amato”…
Per questo, con il supporto della Commissione Toponomastica, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto giusto che il suo nome sia perpetuato attraverso l’intitolazione di un’opera strutturale, di quelle che in gran numero egli in vita è riuscito a far nascere, a beneficio di tutta una collettività.