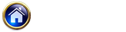Archivio
ricerca per autore
Un consiglio di lettura per questi giorni d’estate. Tre libri di poesia a firma di tre importanti poeti Luigi Amendola, Fabio Dainotti, Mario Rondi.
Luigi Amendola, romano con origini campane, poeta, scrittore e autore teatrale scomparso, purtroppo, a soli quarantasei anni nel 1997. Preziosa la Sua amicizia e l’incondizionata stima per l’Uomo e l’Intellettuale raffinato. A Lui è legato anche il nome di Cava e del Premio Badia del 1994: fu uno dei cinque finalisti con il libro Carteggio del rancore (Mancosu Editore, 1993). Non risparmiò lodi alla nostra città e ai suoi magnifici portici ” sembra di stare a Bologna”. Mi promise che sarebbe ritornato, ma ahimè …
 da Luigi Amendola Lettera a Telemaco, Bizzarro Books, Giugno 2023
da Luigi Amendola Lettera a Telemaco, Bizzarro Books, Giugno 2023
Marzo è di tiglio che confonde
i viali abrasi al transito,
gli scrosci improvvisi, la luce.
In questa prima vera stagione
che di mimose e azalee profuma
le stanze, il cuore sa intuire,
oltre la sua parvenza velata,
quell’attesa di feria solare,
chimera alla risacca marina.
Una ricerca metrica “danzante”, elegante, dolcemente velata in giochi di rime al mezzo e guizzi di sospese inarcature. Estrema raffinatezza di stilemi che si contorcono e si abbracciano ora togliendo il respiro ora donando essenze vitali al sogno, ecco “ i viali abrasi al transito” in un mese di Marzo che ha nel tiglio l’emblema della sua ambiguità e così tra “scrosci improvvisi”, eccoti la luce. Non è forse marzo l’inizio di ogni viaggio, di ogni divenire? “ Tempo era dal principio del mattino; / E il Sol montava in su con quelle stelle/ Ch’ eran con lui, quando l’amor divino/ Mosse da prima quelle cose belle “ ( Dante, Inferno Canto I° , VV 37/40). Sembrerebbe, quindi, che con il segno dell’Ariete, giunga la sospirata primavera, ma neppure una consolidata consuetudine salva l’eterno dubbio del poeta, che domanda e si domanda e poi risponde e si risponde. Ed ecco che, per il poeta, giunge la “prima vera stagione “ non la primavera, una delle quattro stagioni dell’anno, ma la prima vera stagione dell’anno, della giovinezza, della vita stessa. E’ un canto non ostentato né celebrato, è un canto intimistico, dove il profumo delle mimose e delle azalee si rintana nelle stanze (l’uso dell’inarcatura è esemplare: perfetta sospensione che detta il tempo dell’attesa dell’arrivo del profumo nelle stanze). Non può il poeta non sentire sin dal profondo questo arrivo, questo messaggio di luce e profumi: ecco, il cuore sa intuire, il cuore che va al di là del mutevole e della parvenza velata” (come di leggera foschia primaverile), messaggero di una prossima esplosione di estate, di attesa di feria solare, ma il tutto appare malinconicamente solo parvenza, solo una chimera, un sogno primaverile, nel difendersi dal sopraggiungere del mancato abbraccio del mare “risacca marina”. Emblema della disillusione che accompagna il cammino dell’uomo nella sua breve stagione di vita.
Bimba
Veste una seta azzurra che la brezza, entrando
dalle finestre e dalle tende, agita.
Fuori una grande pace è nel giardino.
Solo una bimba gioca
sul ghiaino celeste tra le aiuole
di ortensie e di gerani, tra ombra e sole.
Agli uccelletti, cui sue miche tira,
parla; e s’adira.
Agropoli 1964
da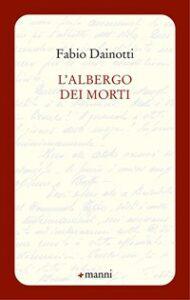 Fabio Dainotti L’albergo dei morti Manni, ottobre 2023 pp.185 euro 18,00
Fabio Dainotti L’albergo dei morti Manni, ottobre 2023 pp.185 euro 18,00
L’albergo dei morti, quasi opera omnia di questo importante poeta nato a Pavia nel 1948 e residente da molti anni a Cava. Libro prezioso e fondamentale per uno studio del suo percorso poetico iniziato fin da giovanissimo. Non a caso, ho scelto questa lirica scritta quando il poeta era poco più che adolescente a testimonianza di una precoce maturità di scrittura. A uno sguardo disattento e frettoloso sarebbe facile etichettare “Bimba” come una breve poesia “quadrettistica” fine a se stessa: una bambina che gioca in un giardino. Ma, a ben guardare ecco che vi si scopre un articolato intreccio ritmico frutto di un sapiente uso di figure retoriche sia di suono sia di ordine sia di significato. Rappresentazione “pittorica”, inizialmente, di due piani contrapposti eppur contigui nell’assenza/presenza di una bimba. I primi due versi sono caratterizzati da un ripetuto intreccio dal ritmo assonantico: dall’incipit Veste/finestre/tende con al centro azzurra/brezza. Chiude il suono cupo: agita contrapposto subito a Fuori è pace dell’inizio del terzo verso. Ecco la protagonista: la vediamo, è una bimba che, con una gran pace del giardino, gioca (in antitesi con l’agitarsi della brezza). Stati emozionali diversi e contrapposti. L’intreccio ritmico si fa più sostenuto ancora: giardino- in rima al mezzo- è in relazione con ghiaino così celeste con veste del primo verso con vibrante rima baciata negli ultimi quattro versi: aiuole/sole e tira/s’adira. Il tutto, ad una lettura disattenta, come detto, apparirebbe da quadretto semplicistico quasi banale: una bimba gioca in un giardino fiorito e intanto lancia briciole agli uccelletti, ma, ecco in chiusura lo scatto del poeta: la bimba s’adira. Simbiosi assonantica con l’agitarsi della brezza del secondo verso. Uno scoppio improvviso che rompe l’incantesimo elegiaco. Non tutto è vero, non tutto è pace, quasi quadretto panistico, la bimba s’adira. Perché? Con chi s’adira? È il dettato impressionistico lirico dell’afflato poetico che non dà risposte rassicuranti ed esaustive, ma spinge alla ricerca del misterioso fare, del misterioso vivere dell’uomo anche nell’ apparente, scontata azione del vivere quotidiano, come di una bimba in un giorno di sole che mentre lancia briciole di pane agli uccellini, si adira.
“Il poeta che canta gli ortaggi” Questo il titolo di un video che la Rai, per l’Expo 2015, dedicò al poeta bergamasco Mario Rondi intervistandolo presso il suo rifugio, una baita in alta montagna dove ama rifugiarsi e scrivere oltre a coltivare un ampio orto giardino motivo ispiratore dei suoi versi. “L’orto è per me l’emblema della scrittura e della poesia”; il mio è uno “zappare con le parole”. Rondi, autorevolmente, s’inserisce in un’antica tradizione di poeti che cantano l’umanità attraverso un mondo in cui frutti, ortaggi, fiori hanno pregi e vizi degli uomini. Si pensi al poema in lingua napoletana di Francesco Antonio Nunziante “Le piante pensanti” (1823) che rifacendosi a Esopo aspirava a esporre il suo “morale sapere” attraverso i “vegetanti” o ad alcuni poeti come Totj Scaloja, Vito Riviello o Nico Orengo. Un genere di poesia, sottilmente ironica, particolare, che oggi non trova, purtroppo, molti estimatori. Ma si farebbe un grave torto a Rondi etichettarlo come “Il poeta che canta gli ortaggi” come un autore dalla “voce” limitata e limitante: è per questo che ho scelto, dalla sua voluminosa Opera Omnia, una lirica dalla cifra poetica illuminante.
Passaggio
( in ricordo di Padre Turoldo)
Qualcosa d’indistinto, un riflesso
nell’onda, il riverbero di un sogno
sulle acque viaggiava genuflesso
nella calda preghiera con bisogno
d’attestare, non visto, il permesso
di passare radente il cotogno
come segno fugace di speranza
nel cuore che prepara la sua danza .
 da Mario Rondi Poesie e Prosa, volumi 4, Genesi Editore, aprile 2023, pp. 2.608, Euro 160,00
da Mario Rondi Poesie e Prosa, volumi 4, Genesi Editore, aprile 2023, pp. 2.608, Euro 160,00
Schema classico: versi endecasillabi divisi in tre strofe, prime due terzine e distico finale. Rima ABA /BAB/ C/C. Nell’incipit contraddistinto da un alone di indeterminazione “ Qualcosa d’indistinto”, subito si palesa, attraverso “un riflesso nell’onda”, la rifrazione, il bagliore di un dato nel riverbero della luce sull’acqua mutevole e fragile come frutto di un sogno che fa comparire senza esplicitarla la figura di Turoldo: genuflesso in preghiera con l’ardente desiderio, anzi il bisogno di oltrepassare silenziosamente quasi come ombra il mondo naturale qui rappresentato da un albero di cotogno, “passare radente il cotogno” con nel cuore “ il segno fugace di speranza”. E la Natura, res naturalia, così care al poeta Rondi, a fare da cornice, interpreti eppure modeste e discrete nel loro ruolo di compartecipi dell’intero Creato. Nulla è certo nel disegno divino, ma d’aiuto è ben forte la speranza covata in cuore per l’agognato anelito finale.
Per il centenario della nascita del poeta lucano Rocco Scotellaro.
Il poeta Rocco Scotellaro nasceva esattamente cento anni fa e moriva a soli trent’anni il 15 dicembre 1953. Di seguito una mia poesia a lui dedicata e il mio ricordo tratto da Italian Poetry del 12 dicembre.
A ROCCO SCOTELLARO
Non so se il tempo disegnerà
versi incantati e fragili
a dispetto di un fiore
che continuamente muore
a muta memoria nel loro farsi
unico respiro. Lucania,
compagna dolce e sconosciuta,
rivoli di capelli neri.
Ancora lontana è la primavera.
Antonio Donadio
ROCCO SCOTELLARO, IL CENTENARIO DELLA NASCITA.
“ E’ fatto giorno, siamo entrati in giuoco anche noi / con i panni e le scarpe e le facce che avevamo.” Versi arcinoti di Rocco Scotellaro richiamati da Carlo Levi nella presentazione al volume postumo “E’ fatto giorno” (1954), pochi mesi dopo l’improvvisa prematura morte del giovane poeta lucano. Versi come pietre di uno sperato, agognato riscatto di un popolo dimenticato, relegato ai margini del vivere sociale. Essere finalmente “ entrati in giuoco” del grande ritmo vitale e sociale della neonata Repubblica Italiana. Ma questi Ultimi sono entrati in gioco non da vittime dolorose e piangenti, ma fieramente “con i panni e le scarpe e le facce” di sempre. Nulla è mutato in loro. E’ questo che fa di Scotellaro un poeta “diverso” da altri poeti lucani/meridionali. Non indossa l’abito della festa per sedere al tavolo dei grandi; alto e fiero della fierezza del suo popolo, degno e fiero anch’esso. Non lamentazione sterile e miserevole per invocare, anzi per pretendere una più onorevole e giusta qualità di vita. Panni, scarpe e soprattutto facce: quelle di sempre. Poeta realistico, quindi, Scotellaro? Direi, ma solo in parte. Egli non rappresenta, non racconta il reale né lo interpreta, ma lo vive, non da personaggio ma da persona. “Poeta della libertà contadina”, come affettuosamente lo chiamava Carlo Levi, si fa emblema di un popolo, quello contadino appunto, quello dell’ “Uva puttanella”, dimenticato, emarginato da sempre. Lontano dalla denuncia sociale dell’amico Levi che da uomo colto del Nord “legge” il sud da spettatore pur con occhi partecipi e solidali, né da Leonardo Sinisgalli, lucano di Montemurro trapiantato a Milano. E dalla lontana Milano, lontana nello spazio e nei moderni ritmi vitali, che racconta la sua Terra, velata di ricordi dolorosi. In lui il reale sfugge a una connotazione temporale per assumere connotazioni intimistiche proprio dell’anima di questo poeta ingegnere che vive e osserva, ma la sua non è pura contemplazione, è un inglobare il reale in sé che si fa memoria. Ben diverso anche un raffronto con un altro poeta meridionale, Salvatore Quasimodo emigrato al Nord come Sinisgalli. Lontana è la sua Terra, la sua Sicilia, lontani gli affetti più cari, lontana la sua cara madre, cui riserva versi: “ Finalmente, dirai, due parole / di quel ragazzo che fuggì di notte con un mantello corto/e alcuni versi in tasca. Povero, così pronto di cuore/ lo uccideranno un giorno in qualche posto.” E’ il suo un addio dettato da un patos tutto interiore, un moto dell’animo rivolto a un incerto e forse pericoloso futuro. Sarà diverso, come vedremo, l’allontanarsi di Scotellaro dalla sua terra nativa. E allora incontriamolo questo giovane, giovanissimo poeta, troppo presto mancato. La sua è una scrittura lontana da effetti di maniera, tipici topoi manieristici, (come si concilierebbe, poi, uno scritto “di maniera” per una rappresentazione passionale e fieramente vissuta ?). Nessun effetto letterario, estetizzante se non progettualmente rappresentativo di un narrare viscerale, puro. Scotellaro non scrive per piacersi e compiacersi, né per piacere al lettore, ma per entrare in sintonia con lui scrivendo ciò che vive, che vive anche il suo lettore o che ha vissuto, che hanno vissuto da generazioni i suoi concittadini, la gens lucana, i basilischi di un tempo anche non troppo lontano. Il suo è un verso apparentemente piano, a volte discorsivo, ma a ben vedere, è un verso nervoso, scalpitante come un mulo che riposa dopo la dura fatica quotidiana “la luna piena riempie i nostri letti/ camminano i muli a dolci ferri”.
E anche la sua breve vita fu contrassegnata da un continuo andare, dalla nativa Tricarico a Sicignano degli Alburni, a Cava de’Tirreni per frequentare la Scuole Media presso il Convento dei Cappuccini “il padre m’inchiodava la cassa/la sorella mi cuciva le giubbe/ed io dovevo andarmene studiare/ nella città sconosciuta!” e poi a Matera, Roma, Trento, Bari e poi Napoli “Ora forse devo andarmene zitto/ senza guardare indietro nessuno, / andrò a cercare un qualunque mestiere” fino a Portici dove, purtroppo, per un attacco cardiaco perse la vita a soli trent’anni, esattamente settant’anni fa, 15 dicembre 1953. Ma la presenza viva in sé della sua Terra non l’abbandonerà mai “ Tornate ai vostri cieli passere./il sole non ci burla, ecco riappare, /è quello di sempre, ha gli occhi crudi/per questi poveri uomini nudi”. Versi di una forza enunciativa emozionale: le passere devono tornare ai propri cieli, l’amico sole che non abbandona mai, è pronto a riapparire -attraverso uno stupendo uso della sinestesia- con occhi nudi per degli uomini poveramente ignudi. Basterebbero solo questi versi a delineare la cifra poetica personalissima e potente di Scotellaro. Ma il giovane Rocco, fiero nelle sue battaglie civili in difesa dei diritti degli ultimi, pagò un prezzo altissimo. Nel febbraio del 1950, nelle funzioni di sindaco di Tricarico, fu arrestato per concussione, condannato al carcere e poi assolto non solo “perché il fatto non costituisce reato”, ma la Corte di Appello di Potenza parlò in modo inequivocabile di “vendetta politica”. Quel poeta che nella sopraccitata poesia “E’ fatto giorno”, solo un anno prima di morire così scrive: ” Allungate i passi, papi e governanti/alla luce degli scalzacani che vi hanno smentito./ Perché nel cielo si alza il sole/e dice tutte le verità, anche di voi,/che per farvi accettare/ci togliete il cuore e la lingua./ dice che due tizzoni fanno il fuoco/ stasera nelle casupole affumicate.” E forse, piace pensare, che uno dei due tizzoni, si sentisse lo stesso Rocco Scotellaro, un tizzone che fa luce prepotentemente da “povere casupole affumicate “ e che ormai fatto giorno “ ci si augura che “la notte non sarà più scura e silenziosa”.
Su Costellazione Parallela Poetesse italiane del Novecento a cura di Isabella Leardini, Vallecchi 2022
“Se un vostro figlio vuole fare lo scrittore o, peggio, il poeta, sconsigliatelo fermamente. Se esiste, intimatogli più fermamente di smettere. Se continua, minacciate di diseredarlo o di togliergli il vostro affetto. Oltre queste tre prove, se resiste, cominciate a ringraziare Dio di avervi dato un figlio ispirato, diverso dagli altri, e lasciatelo fare, aiutandolo moderatamente, cercando di capire, senza troppe parole, il mondo che gli si agita dentro”.
 Così Grazia Deledda in un libro di suoi ricordi. “Se vostro figlio… ” credo che la Deledda non facesse distinzione di genere, ma c’è da chiedersi e se, mutuando il titolo del bel libro di Isabella Leardini, questa “costellazione parallela” non ci fosse? Se a voler esser poeta è una donna, lo è e lo è stato una donna? Chi è la donna poeta? ( Guai a dire poetessa ammoniva fermamente Maria Luisa Spaziani della quale ricordiamo l’ insostituibile “Donne in poesia”) . Ma chi è il poeta, femmina o maschio che sia? Ma ancor prima, cos’è la Poesia? Cos’è, per dirla con la Deledda, questo mondo che agita dentro al poeta? Cosa fosse mai la Poesia, lo chiesi a Mario Luzi nella prima mia intervista che il grande poeta mi concesse.
Così Grazia Deledda in un libro di suoi ricordi. “Se vostro figlio… ” credo che la Deledda non facesse distinzione di genere, ma c’è da chiedersi e se, mutuando il titolo del bel libro di Isabella Leardini, questa “costellazione parallela” non ci fosse? Se a voler esser poeta è una donna, lo è e lo è stato una donna? Chi è la donna poeta? ( Guai a dire poetessa ammoniva fermamente Maria Luisa Spaziani della quale ricordiamo l’ insostituibile “Donne in poesia”) . Ma chi è il poeta, femmina o maschio che sia? Ma ancor prima, cos’è la Poesia? Cos’è, per dirla con la Deledda, questo mondo che agita dentro al poeta? Cosa fosse mai la Poesia, lo chiesi a Mario Luzi nella prima mia intervista che il grande poeta mi concesse.
Si era nell’ aprile del 1989 e lo scenario intorno, oggi si direbbe location, sembrava essere fieramente partecipe a un tema così affascinante, lo splendido golfo di Napoli. La risposta mi spiazzò non concedendomi alcuna replica: “ La poesia e la vita al quadrato. Dimmi cos’è la vita e saprai cos’è la Poesia“. “La Poesia è la Vita al quadrato”. Nodale lezione per me giovane poeta e locuzione che divenne poi nel 2014 il titolo di un mio saggio sulla poetica del grande poeta fiorentino.
Eppure il poeta, da sempre, imperterrito insegue l’indicibile, inconsapevole di nulla e di niente attraverso l’uso della parola che si fa urlo, scavo profondo del proprio animo. Parola nata nell’ ungarettiano “delirante fermento” che si fa Poesia: ” Quando trovo/ in questo mio silenzio/ una parola/scavata è nella mia vita/ come un abisso”. E che non ci sia distinzione di genere tra il poeta femmina o maschio, è ben sottolineato dalla Leardini in questo suo volume (Costellazione parallela Potesse italiane del novecento Vallecchi 2022).
E lo fa con una sagace provocazione espressa nel sottotitolo, ma esplicitata chiaramente nell’ampia introduzione: “La scelta di utilizzare fin dal sottotitolo la parola potesse, consapevole che molte autrici oggi rivendicano la maggiore correttezza della forma poete, non è dovuta a ingenuità o soggezione, ma neppure a una pura affermazione della differenza [ ] volutamente e provocatoriamente scelgo di mantener la parola più scomoda e più antica nel nostro immaginario, perché coerente con ciò che desidero affermare: la presenza della storia, non soltanto in valore della differenza ma con esso la necessità di ricostruire e accogliere una tradizione fatta anche di ombre.” Eppure alla fine la Leardini sorprende anche il più avveduto lettore, sovverte persino il significato dello stesso titolo, quasi una verità in absentia: ”…essere una costellazione parallela significa essere finalmente guardate alla stessa altezza. La nostra però è una diversa sfida, per noi e per chi segue i nostri passi il compito è non essere mai più una costellazione parallela“.
In poche parole, esser parti di una Costellazione Unica! Ma veniamo alle poete presenti in antologia: alcune notissime, come Ada Negri, Sibilla Aleramo, Antonia Pozzi, la citata Maria Luisa Spaziani, Cristina Campo, Amelia Rosselli e la molto amata Alda Merini. Altre meno note e altre non inserite.
E a spiegare tale omissione, la curatrice, quasi a mo’ di scusa, ha tenuto a precisare che non ha incluso nomi imprescindibili come quelli di Grazia Deledda o Elsa Morante “ è perché in loro personalmente non ho avvertito la poesia come una vena primaria ma piuttosto come contro canto a un’opera che splende in altra forma”. E di questo “contro canto” la Deledda è stata magistrale interprete ed è per questo che ho ritenuto esemplificativo ricordare in apertura quel suo scritto. E allora, la poesia etichettata come “femminile “? “Non si tratta soltanto del pregiudizio della poesia femminile come emblema di dilettantismo e sentimentalismo, ma di una più sottile gerarchia che investe topoi, temi, forme metriche e lessico: un automatismo interpretativo con cui la poesia delle donne è stata letta, commentata, selezionata. Il canone è soltanto la conseguenza, il riflesso inevitabile di un vizio di sguardo e di una società “.
Ho scelto di non soffermarmi su alcuna delle poetesse presenti in quest’antologia né su alcuna delle loro liriche, ma faccio un’eccezione per Antonia Pozzi, morta suicida a ventisei anni. Figlia unica di genitori dell’alta borghesia milanese non fu mai ostacolata nel suo scrivere; anzi il padre, entusiasta, si era subito prodigato per trovare un ottimo editore per la giovanissima figlia. Ma tutto ciò non le bastava, neppure una brillante laurea in Lettere ma, per esser donna, sottolinea la Leardini: “pagando il doppio delle tasse scolastiche rispetto ai loro compagni di studi”, sentiva la Poesia essere la sua unica interlocutrice e a essa si rivolgeva con dolorose devote parole: “ Poesia che ti doni soltanto/a chi con occhi di pianto/si cerca- /oh rifammi tu degna di te,/ poesia che mi guardi”. (da Preghiera alla poesia, in Parole, Garzanti 1989).
Rileggiamo Talora nell’arsura della via del poeta Camillo Sbarbaro tra sorprendenti affermazioni: “Basta con Verga”, “ Leopardi non è un poeta” !
Mi verrebbe da dire, un po’ polemicamente, alzi la mano chi “conosce” il poeta Camillo Sbarbaro. Quanti sono coloro i quali hanno letto le sue poesie, “sanno” della sua poetica, del suo vivere “sofferto” e molto vicino a noi più di quanto si possa credere. Eppure in questi giorni, “qualcuno” ha riscoperto una sua poesia,” Talora nell’arsura della via” dall’apparente tema in sintonia con l’opprimente caldo di questa nostra estate. Ma questa poesia è molto, molto altro e di più e di un attualità sorprendente benché scritta più di cento anni fa (1914). Testo notevole nel nostro Novecento Italiano egemonizzato in quegli anni da un Dannunzianesimo dilagante.
Talora nell’arsura della via
Talora nell’arsura della via
un canto di cicale mi sorprende.
E subito ecco m’empie la visione
di campagne prostrate nella luce…
E stupisco che ancora al mondo sian
gli alberi e l’acque
tutte le cose buone della terra
che bastavano un giorno a smemorarmi…
Con questo stupor sciocco l’ubriaco
riceve in viso l’aria della notte.
Ma poi che sento l’anima aderire
ad ogni pietra della città sorda
com’albero con tutte le radici,
sorrido a me indicibilmente e come
per uno sforzo d’ali i gomiti alzo…
(da Camillo Sbarbaro “Pianissimo” Edizioni La Voce, Firenze 1914)
Camillo Barbaro, poeta dallo stile asciutto, secco, lontano, molto lontano da qualsiasi compiacimento estetico, qualsiasi retorica letteraria. Stile quasi subìto dal poeta anche al di la della sua stessa volontà e consapevolezza; si sentiva quasi “costretto” a scrivere “quel qualcosa” che gli urgeva dentro. Stile che meglio non avrebbe potuto rappresentare la sofferta presa coscienza del dolore di vivere, sofferta crisi esistenziale che attanagliò il suo animo come quello di un altro grande poeta ligure Eugenio Montale. Il poeta, l’uomo deve smemorasi per continuare a vivere come in questi splendidi versi.
Per una sintetica analisi connotativa del linguaggio, proporrei di dividere questa poesia in tre strofe di cui le prime di quattro versi ciascuna: tutte e tre le strofe terminano con l’uso della figura retorica della Reticenza ovvero i puntini sospensivi sostituiscono quanto è facilmente intuibile. Tre pure sono le Similitudini presenti ai vv.9/10, v.13 e vv. 14 e 15 laddove in ”i gomiti alzo” può riscontrarsi l’uso della Sineddoche.
Nel confronto col linguaggio denotativo, la poesia sembra scindibile in due atmosferiche poetiche: la contrapposizione tra Città e Campagna e la contrapposizione tra Realtà e Sogno, il tutto legato da un anello di congiunzione che è dato dalla funzione del Tempo.
La Città è rappresentata da “arsura della via”, “ ad ogni pietra della città sorda”. La Campagna invece da “un canto di cicala, “ visione/di campagne prostate nella luce”, “ gli alberi e l’acque/tutte le cose buone della terra”, “ l’aria della notte” , “com’albero con tutte le radici”. Come si può intuire hanno valenza negativa: l’arsura e la sordità della città, mentre valenze positive hanno il canto di cicala, la luce delle campagne (laddove , in campagna, diventa luce quello che nella vita cittadina è arsura); gli alberi e l’acque (contrapposte quest’ultime all’arsura della via e la pietrificazione della città sorda contrapposta al muoversi dell’albero con tutte le radici); il termine sorda poi chiama in antitesi “il canto di cicala”.
La sfera poi del Reale e del Sogno è data dai vv. 1/2 (Reale) contrapposti ai vv.3/4 (Sogno-Visione) e ancora i vv.11/12 (Reale) contrapposti ai vv.13/15 (Sogno). L’anello di congiunzione, dicevo, è dato dalla presenza del Tempo espresso in voci inequivocabili: dal “Talora” inteso come: a volte accade che… si passa al “Subito” in contrapposizione a quanto prima accaduto, attraverso “l’ancora” e “Un giorno” (squisitamente riflessione- sensazione temporale) al “poi” finale per una decisione che non lascia possibilità di dubbi: volare come un uccello pur sentendosi un immobile albero, volare sradicando dal suolo le proprie radici che sanno di prigioni.
E’ questo dolore per ciò che fu e non è più, per quanto l’uomo con la sua “civiltà” la sua urbanizzazione, sta togliendo a se stesso, per un recupero non nostalgico né estetizzante della natura, per un afflato umano con “tutte le cose buone della terra” che fa di questa poesia una “nostra” attualissima poesia, cosi travagliati da questa società contemporanea che sembra distruggere irrimediabilmente “gli alberi e le acque” (come sta a dimostrare lo stravolgimento meteorologico di questi anni, dal caldo siberiano, alla desertificazione di ampie parti del pianeta, allo sciogliersi dei ghiacciai con disastrosi fenomeni alluvionali, …) e “tutte cose buone della terra” quelle cose che “bastavano un giorno a smemorarmi” . Smemorarsi, attenzione, non perdita della memoria, ma recupero di memoria storica e psicologica attraverso l’identificazione con la Natura (uomo compreso) affinché il nostro vivere non sia o diventi vivere “da ubriaco” annebbiati dall’alcool del presunto benessere moderno, e lo”stupore sciocco”per l’improvvisa , ormai sconosciuta, salutare “aria della notte” sul viso. Sentirsi “alberi con tutte le radici” pronti al volo e non lasciare che l’anima aderisca “ad ogni pietra della città sorda”.
*****“Basta con Verga”. “ Leopardi non è un poeta” !*****
Certamente il tema centrale di questa poesia non è il caldo eppure credo che un caldo eccezionale possa anche contribuire ad alcune esternazioni molto, molto discutibili:
“Basta insegnare Verga nei licei, non ne possiamo più. Si legga piuttosto il mio “Va dove ti porta il cuore” ha sentenziato la scrittrice Susanna Tamaro (23 maggio c.a.). Inattuale Verga? Non direi proprio. Basterebbe solo ricordare il racconto Rosso Malpelo per un doloroso confronto con il detestato fenomeno del bullismo.
E un paio di anni la poetessa Patrizia Valduca, compagna per molti anni di un altro poeta, Giovanni Raboni, affermò: “Leopardi, è stato un filosofo, un bravo filosofo, ma certamente non è stato un poeta! Era troppo intelligente per essere un poeta, un poeta deve essere stupido ogni tanto e lui non lo era. Scriveva in prosa e poi andava a capo…” “ Descrivendolo così: “Un gobbo di un metro e quaranta che mangiava solo gelato invidioso di Monti”. Offensiva, terribile gratuità!
E per sostenere la tesi che Leopardi non è un poeta, declamò alcuni versi del “L’Infinito” confrontandoli con alcuni versi di una poesia di Pascoli, “L’Aquilone “ concludendo tout court : “Ecco questo è un poeta vero! Poverino Leopardi voleva intensamente essere un poeta ma …. “ Fatta salve l’opinione di ciascuno, mi sembra poco ortodosso da parte della poetessa Valduca mettere a confronto due poesie, scritte l’una nel 1819 (Leopardi aveva 21 anni) con l’altra scritta nel 1897 (Pascoli aveva 42 anni) dimenticando, forse, “la Stessa” che tra le due composizioni vi è uno spazio temporale di circa 80 anni. E che anni: l’intero Ottocento! Ed è proprio certa la Signora Valduca che la lezione del “mancato” poeta Leopardi ” non sia “servita” al “vero” poeta Giovanni Pascoli?
Amara conclusione: se la nostra Letteratura si appresta ad essere scritta e riscritta da “simili autori”, allora prenderò a leggere i romanzi di Liala e brucerò interi tomi di critica letteraria.
Per il Giorno della Memoria
Voi che ancora avete occhi
ditemi
che fu vista partire
su stridere d’ossute rotaie cariche
di giovani increduli lamenti
dietro cime di estreme ultime paure
ditemi che non ritornerà
nelle notti senza luna
che mai più riderà domestica iena
tra stupiti innocenti latrati.
Ditemi
che ancora sarà gioia aspettare
l’alba su guance serene
che è tempo di nuovi sguardi
per occhi di pianto
fattosi crudele fratello.
Antonio Donadio
NdR: da Italian Poetry La Poesia della settimana: Donadio del 30 gennaio 2023