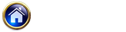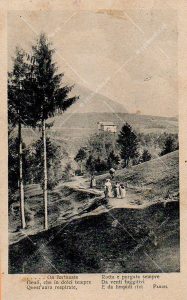Archivio
ricerca per autore
Per il Centenario della nascita di Maria Luisa Spaziani (7 dicembre 1922). “Sarò felice come a Treviglio?”
Da Italian Poetry. La Poesia Italiana Contemporanea dal Novecento a oggi., riportiamo il ricordo del “nostro” poeta Antonio Donadio per il centenario della nascita di Maria Luisa Spaziani (7 dicembre 1922) assieme a una foto, tratta dal nostro archivio, che ritrae la grande poetessa con Antonio Donadio a Roma nei primi anni novanta. (n.d.r.)
“Sarò felice come a Treviglio?” Frase questa che Maria Luisa Spaziani amava spesso ripetere nel corso della sua lunga vita.
“Sono stata felice, a Treviglio, e ogni volta che nella mia vita molto ricca ho vissuto momenti molto belli, il parametro di base è stato Treviglio” così M.L. Spaziani ricordando gli anni (1955/1957) trascorsi a Treviglio come insegnante di lingua francese presso il Collegio Facchetti della cittadina bergamasca. La poetessa (o meglio il poeta, come lei stessa amava definirsi), aveva risposto a un’inserzione sul Corriere della sera: “Cercasi professore per collegio lombardo… ”. Erano anni in cui aveva necessità di lavorare. Il benessere familiare aveva subito un tracollo a causa del grave stato di salute del padre, ripetutamente infartuato, che aveva costretto la famiglia Spaziani a vendere anche la bella casa di Torino. E poi era felice perché Treviglio non era molto distante da Milano ove aveva preso a frequentare Eugenio Montale e allo stesso tempo poteva continuare a dedicarsi alle varie collaborazioni giornalistiche sia con l’autorevole Corriere della sera sia con altre testate minori. Anni dunque, nonostante i problemi familiari, felici. “Treviglio è diventata per me un po’ un’unità di misura. Il collegio è stato l’incontro misterioso della mia vita con la felicità e con un massimo di creatività poetica. E’ stato quello che i mistici chiamano” uno stato di grazia”. Un’ inspiegabile favola che mi ha ispirato le poesie di “Luna Lombarda”(1957). Premio Lerici, 1958. Opera che si apre con i versi di Suite per A.
E’ un piccolo canzoniere d’amore (nove poesie di solo otto versi divisi in due quartine) dove la A. sta per Albignano, frazione di Truccazano località non lontano da Treviglio. Ma questa dedica ad Albignano è un espediente ingannevole: in realtà è l’iniziale di un giovane, un collegiale, amato dalla giovane poetessa. Lo svelamento di questo depistaggio è la stessa Spaziani a fornircelo laddove in “Quartine per una piccola città” recita: “Addormentarmi nel nome di Treviglio/che Albignano fu detta e che non è”.
E allora spulciamo qua e là tra i versi di questo canzoniere a ricercar le orme di questo giovanile amore di quella che sarebbe diventata una delle più importanti poetesse (o poeti) del nostro Novecento. E allora non si può che riportare integralmente Suite per A.
“Rimarrà su deserti lontani,/oltre le praterie del tempo./Baci, roveti, fiamme d’autunno/e un lungo addio tre le mani./Ritornerà con le nuvole, con le stagioni, /tremando ebbrezze seppellite:/ottenebrato, inutile, senza respiro.”
Da notare i due tempi futuri “Rimarrà” e “Ritornerà”: la poetessa si rende conto che quello che sta vivendo non è un capriccio giovanile e passeggero ma un “qualcosa” che è entrato in lei e che in lei rimarrà per sempre come dimostrato poi per l’intero arco della sua vita nel rimando felice di quegli anni di Treviglio.
Il mini canzoniere, dopo questo incipit/dedica, si apre con un riferimento aulico, classico: il suicidio per amore della poetessa Saffo che, non corrisposta dall’amato Faone, si gettò in mare dalla rupe di Leucade “Da rupi ben alte mi sono gettata per te,/alte come la notte o la solitudine.” Un fatto tragico che, però, nei due versi successivi, lascia spazio a un seguito scherzoso: “Ma sotto c’eri ancora tu a cogliermi/col balzo agile della pallavolo”. Nei due versi finali ritorna il riferimento classico, ecco la luna leucade che si trasmuta in luna lombarda della Bassa che sperde nel vento, come foglie, i volti dei due innamorati. “ Arde la luna si questa Leucade della Bassa /e il vento risucchia via i volti, come foglie”. Luna che ritorna ancora nei versi di chiusura della poesia seguente: “Quella luna un po’ triste è restata/per sempre, con la sua frangia di carta.”. Da notare quel “per sempre” e la consapevolezza, per la giovane insegnante, della fragilità temporale di quest’amore ove la luna fa da testimone ma “con la sua frangia di carta”. Storia d’amore vissuta in un’ordinaria quotidianità che in lei assume valenze inaspettate “ i letti sapevano di meliga; o lei che sedeva a tavola con lui di fronte dall’altro capo come a corte “ La tavolata immensa, come a corte, /tu da un lato, io dall’altro.” quasi richiamo alla storia d’amore tra Ginevra e Lancillotto e, laddove, perfino l’acqua di fonte del collegio che pur il mattino era freddissima “l’acqua il mattino spezzava le mani” diviene elisir incomparabile, testimone di una quasi sacralità laica“Non c’è al mondo liquore inebriante/come l’acqua di fonte del collegio./La si beve in bicchieri spessissimi/molto simili a lumi d’altare”. Ed è in quest’aurea vitale, seppure la bella stagione stava volgendo al termine “ Ai primi freddi”, che ha inizio il loro idillio”Fu in quell’aria di felce che parlammo/insieme, leggermente, la prima volta”. Quell’“insieme” e quell’avverbio “leggermente” come sussurro per un sentimento discreto, timido e anche un po’ impaurito a segnare una levità d’atmosfera quasi a richiamare le dolci parole d’amore di Francesca per suo cognato Paolo nell’ Inferno dantesco. Nulla di morboso di cui vergognarsi, quindi. E poi nelle poesie successive i vari momenti d’amore, come un viaggio nella vicina Milano “ Nel cuore di Milano attraversammo/ quella notte remore pinete”, ma la temporalità non ferisce, non rattrista“ Fu un viaggio interminabile sull’arco/ che dal mio tempo guida al tuo.“ o giorni al collegio tra” mura malinconiche” che però non intristiscono“Il ritornello come un mare in furia/morse, assalì le mura malinconiche, /con te mi ritrovai presa in un vortice/di sole e gioia, al salto dei delfini”. Ma Albignano che è servito da depistaggio, alla fine ritorna, e con essa ritorna anche la luna in un lirismo che sarebbe un delitto non riportare integralmente: “Albignano, fiorivano i ciliegie/lungo i tuoi fianchi gracili, riversi. /Su i miei campi riarsi, tra i miei versi/splendeva il grano // Tu mi desti la timida luna/che nei capelli da tempo mi brilla, / la scintilla di grazia, la fortuna/del quadrifoglio tra due rotaie“ Ed essi nella natura si fecero Natura, mi verrebbe da dire. Versi splendidi che mi hanno riportato alla mente la leggenda d’amore tra Filemone e Bauci cantata da Ovidio nelle Metamorfosi: per amore, lui tramutato in Quercia e lei in Tiglio. Per sempre insieme. Ma la poetessa sa che la loro storia è destinata a finire pur se la luna resterà testimone di quest’amore “che nei capelli da tempo mi brilla”. Le loro due vite si separano come due rotaie in un eterno viaggio parallelo senza più possibilità d’incontro.
Un’antica cartolina del 1916 con versi di Parini per un fante in Zona di Guerra nell’inferno della Prima Guerra Mondiale
…… Oh fortunate
Genti, che in dolci tempre
Quest’aura respirate,
Rotta e purgata sempre
da venti fuggitivi
e da limpidi rivi
Giuseppe Parini
Sono versi di Giuseppe Parini tratti dall’ode La salubrità dell’aria (dalle Odi, 1791). Potremmo definirlo un ecologista ante litteram (e pensare che Parini è un poeta ormai dimenticato e solo raramente studiato!). La Poesia in questo caso diventa mezzo di denuncia, impegno sociale e civile. Ma non è di questo che voglio parlare, oggi 21 marzo 2022, Giornata Mondiale della Poesia, ma, purtroppo di qualcosa d’altro, di tremendo: di questi giorni che stiamo vivendo per una STORIA fatta da uomini che amano sempre gli stessi errori, gli stessi orrori e da ALTRI UOMINI che sconosciuti ed eroici illuminano quella medesima STORIA.
Questi versi sono a corredo di una cartolina postale illustrata: un dolce ameno paesaggio collinare con centro un viottolo dove passeggiano serenamente donne e bambini. Il fondo s’intravede una casetta, emblema di un sicuro rifugio che ben illustra i versi del poeta lombardo. Ma quest’antica cartolina ha una data e un destinatario molto particolare. Venne spedita da Caserta il 14 SETTEMBRE 1916. Il mittente è M. R. che scrive a suo fratello F. R. SOTTOTENTE DI FANTERIA PRESSO IL 53° FANTERIA OSPEDALE N. 81mo CALALZO, ZONA DI GUERRA.
Siamo in piena Prima Guerra Mondiale (1915/1918). Calalzo di Cadore, centro nelle dolomiti bellunesi, con la sua linea ferroviaria fu fondamentale per lo spostamento delle truppe in quella Zona di Guerra. Lì si combatté una massacrante guerra di posizione dove fanti, alpini e bersaglieri contarono una perdita di vite umane che sfiorò il numero di mille unità.
E’ straziante pensare a questo giovane sottotenente di fanteria che in ZONA DI GUERRA, riceve questa cartolina, ora, quasi laica reliquia, fra le mie mani, da suo fratello ove i versi del Parini e l’illustrazione rimandano a un mondo di serenità, di pace, fosse anche quella data da momenti di semplice quotidianità.
Come è dolce pensare che quella cartolina gliela abbia consegnata un poeta: E.A. Mario. Infatti, non tutti sanno, che con l’entrata in guerra dell’Italia nel maggio del 1915, E A. Mario, poeta napoletano e impiegato postale, ottiene dalla Direzione delle Poste, l’autorizzazione a viaggiare nelle unità ambulanti postali addette al trasporto della posta in prima linea. E nel giugno del 1918, nasce la celeberrima “Leggenda del Piave” che diviene da subito quasi un inno nazionale.
In questi giorni di lutto, di distruzione e di sofferenze inenarrabili, mi è sembrato giusto, oggi 21 marzo, rendere omaggio non solo alla Poesia, indicibile compagna di spirito e mente, ma sopratutto a tutti coloro, sconosciuti eroi, che ieri come oggi con il loro sacrificio illuminano questo nostro cammino di uomini di terra.
P.S. La cartolina fa parte di una mia collezione privata di cartoline postali (dal 1914 agli anni ‘40) di paesaggi con versi di poeti famosi (Leopardi, Carducci, Ariosto, Pascoli, …)
BASTA GUERRE
Ricevo e pubblico volentieri questi versi dell’amico poeta Giancarlo Zizola.
Nessun commento né lettura critica da parte mia: l’orrore per la guerra cadenza solo un mortale lugubre ritmo.
ASSEDIO
Lungo i marciapiedi
un vuoto da raschiare
con la spietata lucidità
di manifesti a brandelli,
e un odore di morte
che si nutre del vento.
Ma tra i resti delle case,
nel fuoco del fuoco
sempre acceso, c’è ancora
chi spezza il pane
come fosse cibo eterno.
Giancarlo Zizola