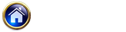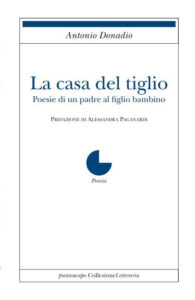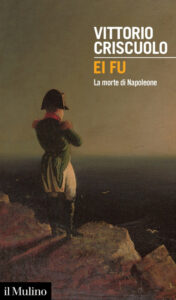PoesiadelNovecento – I Contemporanei
Poesie di poeti noti e meno noti del panorama letterario italiano … di Antonio Donadio
Per il Centenario della nascita di Maria Luisa Spaziani (7 dicembre 1922). “Sarò felice come a Treviglio?”
Da Italian Poetry. La Poesia Italiana Contemporanea dal Novecento a oggi., riportiamo il ricordo del “nostro” poeta Antonio Donadio per il centenario della nascita di Maria Luisa Spaziani (7 dicembre 1922) assieme a una foto, tratta dal nostro archivio, che ritrae la grande poetessa con Antonio Donadio a Roma nei primi anni novanta. (n.d.r.)
“Sarò felice come a Treviglio?” Frase questa che Maria Luisa Spaziani amava spesso ripetere nel corso della sua lunga vita.
“Sono stata felice, a Treviglio, e ogni volta che nella mia vita molto ricca ho vissuto momenti molto belli, il parametro di base è stato Treviglio” così M.L. Spaziani ricordando gli anni (1955/1957) trascorsi a Treviglio come insegnante di lingua francese presso il Collegio Facchetti della cittadina bergamasca. La poetessa (o meglio il poeta, come lei stessa amava definirsi), aveva risposto a un’inserzione sul Corriere della sera: “Cercasi professore per collegio lombardo… ”. Erano anni in cui aveva necessità di lavorare. Il benessere familiare aveva subito un tracollo a causa del grave stato di salute del padre, ripetutamente infartuato, che aveva costretto la famiglia Spaziani a vendere anche la bella casa di Torino. E poi era felice perché Treviglio non era molto distante da Milano ove aveva preso a frequentare Eugenio Montale e allo stesso tempo poteva continuare a dedicarsi alle varie collaborazioni giornalistiche sia con l’autorevole Corriere della sera sia con altre testate minori. Anni dunque, nonostante i problemi familiari, felici. “Treviglio è diventata per me un po’ un’unità di misura. Il collegio è stato l’incontro misterioso della mia vita con la felicità e con un massimo di creatività poetica. E’ stato quello che i mistici chiamano” uno stato di grazia”. Un’ inspiegabile favola che mi ha ispirato le poesie di “Luna Lombarda”(1957). Premio Lerici, 1958. Opera che si apre con i versi di Suite per A.
E’ un piccolo canzoniere d’amore (nove poesie di solo otto versi divisi in due quartine) dove la A. sta per Albignano, frazione di Truccazano località non lontano da Treviglio. Ma questa dedica ad Albignano è un espediente ingannevole: in realtà è l’iniziale di un giovane, un collegiale, amato dalla giovane poetessa. Lo svelamento di questo depistaggio è la stessa Spaziani a fornircelo laddove in “Quartine per una piccola città” recita: “Addormentarmi nel nome di Treviglio/che Albignano fu detta e che non è”.
E allora spulciamo qua e là tra i versi di questo canzoniere a ricercar le orme di questo giovanile amore di quella che sarebbe diventata una delle più importanti poetesse (o poeti) del nostro Novecento. E allora non si può che riportare integralmente Suite per A.
“Rimarrà su deserti lontani,/oltre le praterie del tempo./Baci, roveti, fiamme d’autunno/e un lungo addio tre le mani./Ritornerà con le nuvole, con le stagioni, /tremando ebbrezze seppellite:/ottenebrato, inutile, senza respiro.”
Da notare i due tempi futuri “Rimarrà” e “Ritornerà”: la poetessa si rende conto che quello che sta vivendo non è un capriccio giovanile e passeggero ma un “qualcosa” che è entrato in lei e che in lei rimarrà per sempre come dimostrato poi per l’intero arco della sua vita nel rimando felice di quegli anni di Treviglio.
Il mini canzoniere, dopo questo incipit/dedica, si apre con un riferimento aulico, classico: il suicidio per amore della poetessa Saffo che, non corrisposta dall’amato Faone, si gettò in mare dalla rupe di Leucade “Da rupi ben alte mi sono gettata per te,/alte come la notte o la solitudine.” Un fatto tragico che, però, nei due versi successivi, lascia spazio a un seguito scherzoso: “Ma sotto c’eri ancora tu a cogliermi/col balzo agile della pallavolo”. Nei due versi finali ritorna il riferimento classico, ecco la luna leucade che si trasmuta in luna lombarda della Bassa che sperde nel vento, come foglie, i volti dei due innamorati. “ Arde la luna si questa Leucade della Bassa /e il vento risucchia via i volti, come foglie”. Luna che ritorna ancora nei versi di chiusura della poesia seguente: “Quella luna un po’ triste è restata/per sempre, con la sua frangia di carta.”. Da notare quel “per sempre” e la consapevolezza, per la giovane insegnante, della fragilità temporale di quest’amore ove la luna fa da testimone ma “con la sua frangia di carta”. Storia d’amore vissuta in un’ordinaria quotidianità che in lei assume valenze inaspettate “ i letti sapevano di meliga; o lei che sedeva a tavola con lui di fronte dall’altro capo come a corte “ La tavolata immensa, come a corte, /tu da un lato, io dall’altro.” quasi richiamo alla storia d’amore tra Ginevra e Lancillotto e, laddove, perfino l’acqua di fonte del collegio che pur il mattino era freddissima “l’acqua il mattino spezzava le mani” diviene elisir incomparabile, testimone di una quasi sacralità laica“Non c’è al mondo liquore inebriante/come l’acqua di fonte del collegio./La si beve in bicchieri spessissimi/molto simili a lumi d’altare”. Ed è in quest’aurea vitale, seppure la bella stagione stava volgendo al termine “ Ai primi freddi”, che ha inizio il loro idillio”Fu in quell’aria di felce che parlammo/insieme, leggermente, la prima volta”. Quell’“insieme” e quell’avverbio “leggermente” come sussurro per un sentimento discreto, timido e anche un po’ impaurito a segnare una levità d’atmosfera quasi a richiamare le dolci parole d’amore di Francesca per suo cognato Paolo nell’ Inferno dantesco. Nulla di morboso di cui vergognarsi, quindi. E poi nelle poesie successive i vari momenti d’amore, come un viaggio nella vicina Milano “ Nel cuore di Milano attraversammo/ quella notte remore pinete”, ma la temporalità non ferisce, non rattrista“ Fu un viaggio interminabile sull’arco/ che dal mio tempo guida al tuo.“ o giorni al collegio tra” mura malinconiche” che però non intristiscono“Il ritornello come un mare in furia/morse, assalì le mura malinconiche, /con te mi ritrovai presa in un vortice/di sole e gioia, al salto dei delfini”. Ma Albignano che è servito da depistaggio, alla fine ritorna, e con essa ritorna anche la luna in un lirismo che sarebbe un delitto non riportare integralmente: “Albignano, fiorivano i ciliegie/lungo i tuoi fianchi gracili, riversi. /Su i miei campi riarsi, tra i miei versi/splendeva il grano // Tu mi desti la timida luna/che nei capelli da tempo mi brilla, / la scintilla di grazia, la fortuna/del quadrifoglio tra due rotaie“ Ed essi nella natura si fecero Natura, mi verrebbe da dire. Versi splendidi che mi hanno riportato alla mente la leggenda d’amore tra Filemone e Bauci cantata da Ovidio nelle Metamorfosi: per amore, lui tramutato in Quercia e lei in Tiglio. Per sempre insieme. Ma la poetessa sa che la loro storia è destinata a finire pur se la luna resterà testimone di quest’amore “che nei capelli da tempo mi brilla”. Le loro due vite si separano come due rotaie in un eterno viaggio parallelo senza più possibilità d’incontro.
LA CASA DEL TIGLIO Poesie di un padre al figlio bambino, ultimo libro di liriche di Antonio Donadio
E’ in uscita in questi giorni, come già riportato in data 13 ottobre u.s. dall’ autorevole sito sulla Poesia del ‘900 , Italian poetry, l’ultimo libro di liriche del poeta Antonio Donadio nonché nostro prezioso curatore di Rubriche di Cultura Poetica. Libro che speriamo, come sempre per precedenti lavori di Donadio, poter presentare, quanto prima, anche qui a Cava.
LA CASA DEL TIGLIO, poesie di un padre al figlio bambino edito da puntoacapo Collezione Letteraria.
Lavoro tematico come si evince dal titolo, una paternità “come categoria dell’anima” come afferma Alessandra Paganardi nella sua ampia e raffinata prefazione di cui, dalla scheda redazionale, pubblichiamo una parte e una lirica:
“ [ ] La casa del tiglio è la cronaca di un sogno divenuto cura e di una cura fattasi sogno: quello di una paternità che va ben oltre l’aspetto biologico e supera persino quello meramente affettivo. In un’epoca di trattati, manuali, tecnicismi educativi e trasbordanti psicologismi, ecco un libro di poesia che sa presentare al lettore la genitorialità come categoria dell’anima. Una genitorialità che precede il figlio, eppure soltanto in esso matura e s’incarna: proprio come il poeta è certamente tale prima del testo, ma si esprime soltanto in esso e intristisce in sua assenza. [ ] . Non ha genere l’attesa, che si palesa all’apertura del libro in data (non casualmente) di maturo avvento, l’antivigilia di Natale: “Chiudi la porta / al giorno delle lunghe / ombre indiscrete / C’è nell’aria / un’attesa bambina / negli angoli di luce”. E non è inutile ricorda partire da questo inizio, quasi ogni verso sia imbevuto di una profonda religiosità laica, che con il rito ha in comune prima di tutto il mistero, la sacralità e persino il paradosso di quella “giovane cosa così più vecchia di me” che, prima del bambino come essere carnale, è la vita stessa.[ ] La casa del tiglio, in cui il piccolo Daniele vive la sua prima estate, richiama la “casa del nespolo” verghiana, alla quale tuttavia si contrappone come l’aurora al tramonto. Se Verga evoca il capolinea – per quanto arginato dai solidi valori della giovane coppia superstite – di tutto un mondo storico e sociale, Donadio prospetta una continuità generazionale che sa garantire la ricarica vitale: e lo fa proprio grazie alla relazione tra genitore e figlio, un rapporto nuovo, forse ancora non molto sperimentato, che mette continuamente in gioco il poeta e il bambino e che trova la sua perfetta espressione nel verso.[ ] A sublimare ulteriormente il dono interviene la separazione forzata, per motivi di lavoro, del poeta dalla famiglia (lontananza segnata assai fortemente dall’invisibile frattura trasversale tra nord e sud, i distanti luoghi di lavoro dei genitori). Ad ogni ritorno si percepisce la necessità di ricucire lo strappo, di medicare la distanza: come se il tempo passato insieme dovesse valere almeno due volte. In questo libro ogni oggetto, ogni minima traccia o linguaggio della natura (il verso degli animali, le foglie, il riflesso del sole, la neve e la nebbia) ha un forte connotato simbolico: si può forse parlare di “realismo simbolico” o di “simbolismo della concretezza”. Forse anche per questo la cifra poetica di Donadio non è mai, se non assai marginalmente, la narrazione. Coerentemente con l’aspetto sacrale di cui abbiamo parlato, questa poesia annuncia piccole epifanie quotidiane che ripetono il primitivo miracolo della vita incarnata, dell’origine. Il linguaggio è forse più vicino a quello largo e formulare dei salmi, con enjambement avvolgenti, chiuse maestose, versi talora ripetuti e con la presenza di una costante seconda persona singolare, che rinvia al dialogo. [ ] Quando la scrittura, come in questo caso, attinge così direttamente alla vita, somiglia più a un poema ininterrotto che a una serie di episodi staccati.[ ]”
Fuochi
E poi vedrai la notte
dalle mille ombre chiare
nuove come quest’anno
che impudico ancora si traveste
di promessa gioia
come un gioco non ancora
tuo. E ti sorriderò
stringendoti al nuovo giorno
e tu gioirai stupito
ai mille fuochi improvvisi.
Buon anno, amore
piccolo tenero fuoco
di un padre terra
senza più fuochi di cielo.
Capodanno 1993
BASTA GUERRE
Ricevo e pubblico volentieri questi versi dell’amico poeta Giancarlo Zizola.
Nessun commento né lettura critica da parte mia: l’orrore per la guerra cadenza solo un mortale lugubre ritmo.
ASSEDIO
Lungo i marciapiedi
un vuoto da raschiare
con la spietata lucidità
di manifesti a brandelli,
e un odore di morte
che si nutre del vento.
Ma tra i resti delle case,
nel fuoco del fuoco
sempre acceso, c’è ancora
chi spezza il pane
come fosse cibo eterno.
Giancarlo Zizola
In libreria: Tutto fu bello qui di Maurizio Zanon, Guido Miano Editore, 2020
Si perpetua ancora una volta l’Amore, quell’Amore impossibile anche da confessarsi. Il brivido ti annienta stordito. E con esso, la vita, quella di tutti i giorni che ti chiama, ti reclama: la pausa è solo semplice pausa, non può dettare legge né tempi oltre un fugace attimo d’incanto. E il poeta riprende a vivere, ma sul foglio veloce rivive quella Voce. Non altro da sé se non quell’esplosione di attimi. Attimi felici questi versi di Zanon, esplosioni che cesellano il vivere, aiutano a capire forse il dettato della propria vita e dei suoi simili, mortali viandanti: è come un amore clandestino che si scopre nell’evolversi dei versi … caduco quest’amore come un “muovere di foglie “… ma forte, coriacea è la figura dell’altra.
Sei la mia vita:
lo so non ci credi, mi guardi stupita
ed in questo muovere di foglie
non sei solo – dici – c’è sempre tua moglie.
E’ una lirica questa di una lievità e durezza insieme: quattro versi soltanto, dove lui, al suo diniego per “c’è sempre tua moglie”, è confuso, farfuglia qualcosa. Quell’inizio del terzo e ultimo verso “ non sei solo – dici –“ così spezzettato: quattro parole ad inseguirsi, (tre trisillabe e tre quadrisillabe), sonoramente ci regala il balbettare di un uomo che non sa cosa rispondere, quasi stupito che l’amante gli ricordi che ha moglie. E’ tutto come un soffio leggero di foglie portate dal vento. E’ la natura che fa da specchio e da testimone in un gioco di riflesse emozioni e sentimenti in queste liriche di Zanon. E in “Fiorito è il sambuco “ non è forse sconfitto anche il presuntuoso ragno che non può far altro che rifugiarsi in un buco “Scappa il ragno dentro a un buco” nell’esplosione del sambuco fiorito mentre la notte ha inizio con un magico momento d’amore: la luna insegue una stella, la più bella dell’intero firmamento? E’ l’esplosione della gioia di vivere che rende la vita bella, veramente bella. Quattro versi in rima dove la rima non solo ha funzione ritmica ma contenutistica, rima non formale ma sostanziale. La vita, la vita che traccia segni, disegni, tracce di sé dietro di sé: un semplice fazzoletto “accuratamente stirato/e smarrito/lungo i binari alla stazione” colpisce il poeta: certamente smarrito ma sorprendentemente stirato (rima in contrapposizione tematica). Ecco un semplice fazzoletto farsi specchio, testimone di un amore, di tutto un amore domestico. Così una piccola cosa detta agli occhi del poeta, al suo sentire, una storia come altre mille di cui non si conoscono né nomi né volti, ma così simili a noi. E il lettore ne rimane coinvolto. In “L’azzurra fuggevole estate”, poi, il dono di un alito di speranza per questi nostri angosciosi giorni.
L’azzurra fuggevole estate
Che luce traspare se il cielo è cupo
se il giorno non dona cose nuove
ma soltanto irrequietezza o depressione?
Ricordo allora quelle bianche vele al sole
quel caldo mare infrangersi sul molo, le voci dei ragazzi
appena sussurrate nell’azzurra fuggevole estate.
Non credo che sia difficile cogliere quanto attuali siano questi versi: primi tre versi in cui nulla di luce traspare se il cielo è cupo, se il giorno non regala più cose nuove, se in noi è solo ansia e apprensione. Ma il cuore ancor prima della mente si rifugia nei ricordi vitali di bianche vele al sole, del frangersi del mare, delle voci festose di ragazzi sussurrate, nell’azzurra fuggevole estate. Estate fuggevole come la giovinezza, versi che richiamano splendide atmosfere penniane. Ma il poeta tace il suo recondito desiderio: tornino, devono tornare ancora queste estati di bianche vele al sole e di mare e di risa di fanciulli.
Maurizio Zanon è nato nel 1954 a Venezia dove risiede. Laureato in Lettere Moderne, pubblica il suo primo libro di versi “Prime poesie” a venticinque anni. Costantemente attiva è la sua partecipazione a momenti culturali/poetici con stimolanti incontri con importanti poeti contemporanei come Diego Valeri, Giovanni Giudici, Andrea Zanzotto, Paolo Ruffilli. Tra le sue numerose pubblicazioni citiamo: Verrà l’estate (1980), Viale delle solitudini (1982), Epigrammi e altre poesie (1985), Poesie d’Amore (1991), La Bianca Alba (1999), Un girasole ho nel cuore (2004 ), Liriche scelte (2010), A ogni prima luce (2012), Luce campestre (2017), Tutto passa (2019). Alcuni suoi libri sono stati tradotti in inglese, francese, spagnolo, tedesco. Ampia e qualificata la rassegna stampa.
Duecento anni fa moriva Napoleone: dal libro di Vittorio Criscuolo (Ei fu. La morte di Napoleone, il Mulino 2021) all’incipit manzoniano dell’ode “Il Cinque maggio”
Napoleone “ presentandosi al mondo con l’aureola del martire” – sconfitto a Waterloo nel giugno del 1815 e dall’ottobre dello stesso anno esiliato per i suoi ultimi cinque anni di vita nella lontana e sperduta isola di sant’Elena in pieno oceano Atlantico Meridionale – “vinse l’ultima delle sue battaglie” ponendo così “il primo fondamento della leggenda”. E che Napoleone Bonaparte a dispetto di quanti, frettolosamente ed erroneamente, avevano ipotizzato che con la sua morte “sarebbe stato presto dimenticato” sia, invece, da quel fatidico 5 maggio 1821, divenuto figura leggendaria, è una delle affascinanti tesi che il lettore può ritrovare in un indispensabile libro appena pubblicato: “Ei fu, La morte di Napoleone, edito da Il Mulino”. Autore è il ch. mo prof. Vittorio Criscuolo, ordinario di Storia Moderna all’Università degli Studi di Milano. Al centro del libro il documento più importante sull’esilio di Napoleone e fonte insostituibile per le ricostruzioni storiografiche: il Memoriale di Emmanuel Las Cases che fu a fianco dell’imperatore nel suo lungo esilio. Il prof. Criscuolo, nativo di Salerno ma residente da anni a Milano, non è nuovo, tra l’altro, ad approfondimenti su Bonaparte (N.d.R. il giovane Napoleone, 1996; Napoleone, 1997; Napoleon, 2003.) In Ei fu, il professore si sofferma anche sull’eco che la morte di Napoleone suscitò in alcuni importanti poeti europei. Non solo sul “nostro” Manzoni che compose la celebre ode “Il cinque maggio” (su cui ritornerò fra poco). L’ode fu tradotta in lingua tedesca da Goethe e Alfhonse de Lamartine, giudicandola “perfetta”, disse che avrebbe voluto averla scritta lui. Molto significativa è, poi, una poesia scritta da Silvio Pellico, che pur molto lontano per orientamenti ideali da Napoleone, volle, da prigioniero nella fortezza dello Spielberg, ricordare il grande condottiero morto nella solitudine della lontana sant’Elena. Da sottolineare anche il capitolo che Criscuolo riserva alla filmografia napoleonica. Film solo in parte agiografici. Alcuni anche di pura fantasia come ipotizzare una “non morte” di Napoleone. Tesi che fu al centro di una sceneggiatura scritta da Charlie Chaplin nel 1936 ma mai realizzata. Il grande attore, ovviamente, avrebbe interpretato il ruolo del protagonista. Tra l’altro viene ricordato dal professore lo sceneggiato “Napoleone a Sant’Elena, prodotto dalla Rai nel 1973 e interpretato da Renzo Palmer per la regia di Vittorio Cottafavi e disponibile su Rai play.
Al libro, il Corriere della sera del 13 aprile ha dedicato una doppia pagina in Cultura a firma di Paolo Mieli che in modo articolato e ricco, introduce il lettore alla scoperta delle 228 pagine del saggio. Devo però segnalare la presenza in quest’ampio articolo di un refuso, uno svarione che questa mia rubrica di cultura poetica non può tralasciare. Scrive Mieli. “ Quando Napoleone morì, Alessandro Manzoni scrisse la celeberrima poesia il cui primo verso dà il titolo al libro di Criscuolo (Ei fu).” Un’inesattezza non solo formale ma sostanziale. Ei fu, infatti, non è il primo verso, come egli afferma, ma l’incipit del primo verso: “Ei fu. Siccome immobile“. Incipit presente fin dalla primissima stesura della famosa ode, riportata dal prof. Criscuolo e qui di seguito:
Ei fu: come al terribile
Segnal della patria
Tutta si scosse in fremito
La salma inorridita,
Come agghiacciata immobile
Dopo il gran punto sta.
Tale al tonante annunzio
Stette repente il mondo
Che non sa quando, in secoli,
L’uomo a costui secondo
La sua contesa polvere
A calpestar verrà.
Un incipit originale e dalla forza poetica straordinaria. Manzoni per indicare un uomo eccezionale come Napoleone Bonaparte, usa il “semplice” pronome personale Ei (Egli) di chiara derivazione dall’Ille latino (quel famoso). Non ne dice il nome. Per annunciare “questa” morte, gli basta una bisillaba Ei fu. Bisillaba che nella sua essenzialità scheletrica, tre vocali e una sola consonante, ”suona” come un sussurro, un soffio (suggerito dall’uso della consonante labiodentale “F”) leggero, appena solcato nell’attonita aria che il punto fermo posto alla fine tronca di netto. Fenomenale traslitterazione poetica: repentino e inaspettato è il passaggio dalla vita all’improvvisa morte. Infatti, non solo Manzoni ma l’Europa intera rimase sgomenta all’inattesa notizia della scomparsa di Napoleone. Questo fantastico, non che efficace, incipit manzoniano, mi porta a ricordare un altro incipit quasi simile: “ Si sta” in “Soldati” di Giuseppe Ungaretti scritta circa un secolo dopo nell’inferno della prima guerra mondiale:
Si sta come
d’autunno
sugli alberi
le foglie.
In quell’incipit “Si sta” è racchiusa la cifra del “dire poetico”. L’uso di quel bisillabo tronco (accento tronco in chiusura e iterazione/anafora della “S”: come di un temuto mortale sibilo di un colpo di moschetto), dà la rappresentazione ritmica della provvisorietà, del veloce accadimento di qualcosa d’ineluttabile. Il come che segue a fine verso, fondamentale l’enjambement, riveste l’aria di sospesa attesa che è soddisfatta, poi, dai versi seguenti “ d’autunno/sugli alberi/le foglie”. Versi che sono solo una rappresentazione scenografica della tragedia che incombe sui soldati. Immaginiamo, per un istante, che Ungaretti avesse scritto “stanno o stiamo”, certamente il concetto non sarebbe mutato, ma sarebbe cambiato tutto, non sarebbe stato un verso di pura Poesia.
Vittorio Criscuolo, nato a Salerno il 1951, ha conseguito la laurea in Scienze politiche presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” nel novembre 1974 con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi di laurea in storia moderna (relatore prof. Armando Saitta) su “Giuseppe Abamonti e il giacobinismo meridionale”, che è stata riconosciuta degna di pubblicazione. Dopo anni come assistente, assegnista e ricercatore presso l’Università romana si trasferisce a Milano. Attualmente ricopre la carica di professore ordinario di Storia Moderna e Storia dell’età dell’illuminismo e delle Rivoluzioni presso l’Università Statale milanese. Fa parte del Collegio del dottorato in “Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni” della medesima Università. Numerose le sue pubblicazioni che sono fondamentale punto di riferimento non solo per i suoi studenti ma anche per studiosi e appassionati di storia moderna.