Sarà presentata a Palazzo di Città in ristampa anastatica la biografia di Carlo Filangieri, cavese doc, grande generale napoletano dell’Ottocento
CAVA DE’ TIRRENI (SA). Sarà un’occasione non solo per riscoprire un protagonista della storia meridionale ma anche per commemorare uno degli figli più importanti e forse più misconosciuti di Cava de’ Tirreni.
Venerdì 17 aprile alle ore 18, presso la Sala di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, sarà presentata la ristampa anastatica del libro Carlo Filangieri, scritto nel 1876 dal Marchese Pietro Calà Ulloa.
Dopo i saluti del Sindaco di Cava de’ Tirreni, Marco Galdi, della Vice Portavoce dell’Associazione Polis sez. Cava de’ Tirreni – Salerno, Anna Casaburi, e del Parroco di Passiano, don Vincenzo D’Amico, relazioneranno: i prof. Emilio Gin (ricercatore di Storia contemporanea dell’Università di Salerno) e Giuseppe Foscari (docente universitario di Storia Moderna presso l’Università di Salerno), Giuseppe Catenacci (Presidente dell’Associazione ex alunni della Nunziatella) e Vincenzo D’Amico, editore dell’opera. Modererà Antonio Di Martino.
L’opera, arricchita dalla prefazione di Giuseppe Catenacci e di Francesco Maurizio Di Giovine, è la biografia di Carlo Filangieri, cavese di origine, prestigioso generale dell’Ottocento Napoletano, figlio del grande filosofo Gaetano.
Notevole l’appendice fotografica e documentaria, in cui spiccano alcuni documenti inediti come il certificato di battesimo di Carlo, una lettera che il generale scrisse in francese a Pietro Quandel, il frontespizio della Scienza della legislazione, con la dedica autografa, che il generale donò ai monaci della Abbazia della Ss. Trinità.
Da segnalare anche alcune cartoline d’epoca di Cava de’ Tirreni, che ritraggono il Palazzo Carraturo (poi Villa Eva) e il suo splendido giardino, dimora natale di Carlo, dove Gaetano scrisse la sua opera più famosa,la già citata Scienza della Legislazione. Il Palazzo è collocato all’inizio di quella via Gaetano Filangieri che tuttora è dedicata al grande filosofo. Di esso, è rimasta solo un’ala, mentre dove sorgevano i giardini, adesso c’è una scuola.
Carlo Filangieri, figlio del celeberrimo filosofo Gaetano e di Carolina Frendel, ungherese, educatrice della Principessa Luisa Maria, figlia di Ferdinando IV, nacque nella città metelliana il 10 maggio del 1784.
Orfano in tenera età, nel 1799, il giovane Carlo, impossibilitato a raggiungere lo zio Antonio in Spagna in seguito alle turbolenze napoletane di quel periodo, a Milano entrò in contatto con l’esercito francese.
In Francia, fu accolto da Napoleone che lo iscrisse al Prytanée, la prestigiosa accademia militare parigina. Combatté nell’esercito imperiale (anche nella storica battaglia di Austerlitz), distinguendosi per il suo valore, fino a quando non fu cacciato dall’Imperatore, che lo definì una “testa di Vesuvio”, per aver sfidato a duello e ucciso il generale corso Francheschi, che aveva insultato l’onore militare dei napoletani.
L’Ulloa ripercorre la lunga carriera militare del generale Filangieri, prima nell’esercito murattiano, poi in quello borbonico. Qui, a causa dei suoi trascorsi francesi, fu richiamato solo intorno al 1830, da Re Ferdinando II.
Durante il regno di Ferdinando II riordinò l’esercito e nel 1848-49 riconquistò la Sicilia, che si era dichiarata indipendente da Napoli. Per alcuni anni fu governatore dell’isola. Ricevette dal Re il titolo di duca di Taormina, mentre precedentemente aveva ereditato il titolo di principe di Satriano.
Carlo Filangieri fu anche imprenditore: a lui appartenevano sia la ferriera di Cardinale, da cui si estrasse il ferro per costruire il ponte Maria Cristina sul fiume Calore, sia una filanda a Sarno.
Tuttavia nella memoria storica egli è rimasto soprattutto come generale di alto profilo. Il brillante giornalista Ansaldo lo definì “il solo grande soldato, la sola testa politica del regime borbonico nell’Ottocento”, mentre Roberto Selvaggi, nella sua monumentale opera “Volti e nomi di un esercito dimenticato”, lo considera il generale napoletano di gran lunga più preparato, colto e intelligente; a suo dire l’unico che avrebbe potuto salvare il Regno di Napoli dalla catastrofe, se fosse stato più giovane e soprattutto se il Re non fosse stato così restio ad affidargli l’impresa.
Morì a San Giorgio a Cremano il 9 ottobre del 1967, nel nuovo stato unitario al quale, grazie al suo senso dello Stato, egli non rifiutò collaborazione ed accoglienza.
- La locandina della manifestazione
- Carlo Filangieri
- La copertina del libro di oggi e quella del libro di ieri
- Il prof. Giuseppe Foscari
- L’editore, e cultore di collezionismo d’epoca, Vincenzo D’Amico
- Giuseppe Catenacci, Presidente dell’Associazione degli ex allievi della Nunziatella
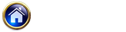


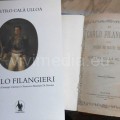



Commenti non possibili