La Cava del Cinquecento e le “Farse Cavajole” di Vincenzo Braca
CAVA DE’ TIRRENI (SA). “Vincenzo Braca e i Cavoti – L’immagine di Cava e dei suoi abitanti nei versi dell’autore delle “Farse”, di Mario Lamberti (Ed. Marlin) è il libro che non c’era, un libro che ci voleva. Ci voleva per sfatare alcuni luoghi comuni sia sulla conflittuale rivalità tra gli abitanti di Cava e quelli di Salerno, sia sulla reale portata sociale e letteraria delle famose farse cavajole, oggi sempre più citate che conosciute, sia sulla figura stessa di quel Vincenzo Braca tante volte “vilipeso” come salernitano mangiacavjuoli.
Mario Lamberti, cavese doc, docente di materie letterarie e Dirigente scolastico in pensione, avvertendo l’esigenza di un lavoro specifico su queste tematiche, dopo un accurato e profondo lavoro di ricerca da par suo, fondendo crocianamente acutezza di intuizione e chiarezza di espressione, ha prodotto un’opera ragionata ed illuminante, corredata di un’ampia ed esauriente documentazione letteraria e poetica, facilmente decodificabile perché, accanto alla lingua “cavota” dell’epoca, non mancano mai le traduzioni corrispondenti.
Il ragionamento di Lamberti parte da una deduzione logica, mutuata anche dai fondamentali studi a suo tempo effettuati dal prof. Achlle Mango.
Al tempo delle farse cavajole, cioè tra il XVI e il XVII secolo, il genere della farsa era già abbondantemente diffuso. Le sue ascendenze remote risalivano nel territorio campano-laziale, addirittura alle farse atellane, culla dell’Italum acetum di oraziana memoria. Le ascendenze recenti, come forma comica popolare di ispirazione laica e non religiosa, risalivano al Medio Evo, in Francia, da cui si erano diffuse poi in Italia, per pervenire a Napoli proprio nel Rinascimento, alla Corte Aragonese, e annoverando un autore nobilissimo in Pietro Antonio Caracciolo.
All’interno di questa corrente si inserisce il genere della farsa cavajola, sbocciato con Vincenzo Braca, che ha una sua specificità perché legato direttamente all’ambiente popolare e cittadino della sola Città de La Cava e realizzato attraverso l’uso della parlata “cavota”, diversa da quella delle zone circostanti. Se è vero che queste opere sono delle satire nei confronti di situazioni, ambienti, categorie e mentalità di una Città carica di contraddizioni ma in galoppante fioritura economica e sociale (e quindi naturalmente soggetta a rivalità e invidie), è anche vero che la figura del cavoto come maschera buffa e come tipo un po’ rozzo e a volte risibilmente goffo e/o presuntuoso era preesistente a Vincenzo Braca. Esisteva infatti già in altri autori, in primis in Masuccio Salernitano (vedi la celebre novella de I due cavoti), in secundis nel già citato Caracciolo, in tertiis nello scrittore Giovambattista Pino.
Il passaggio a maschera comica, secondo Lamberti, è avvenuto perché proprio i Cavoti avevano l’abitudine di andare in giro nei dintorni in alcune feste particolari, come Capodanno e Carnevale, a proporre spettacolini comici e satirici. Quindi il cavoto era un tipo particolare di abitante del territorio, da una parte vivace e creativo, dall’altra non privo di modi buffi e soggetti a derisione. Da questo a trasformare le persone creative in maschere diffuse il cammino non è stato lunghissimo.
Su questa fondamentale premessa, il prof. Lamberti apre un’amplissima finestra su Vincenzo Braca, creando di fatto una monografia che finora non era mai stata scritta da nessuno, così completa e così esauriente. Ed è un viaggio affascinante, il suo, che è miele per la curiosità intellettuale di un cavese di oggi che vuole “affondare” nell’identità storica, ma è nello stesso tempo stimolo per tutti coloro che si appassionano alla letteratura, alle radici della classicità latina, ai suoi gangli con le lingue parlate e le espressioni popolari.
Sono due i punti essenziali che egli sviluppa.
Braca era un salernitano, ma con i cavoti, anche se poi ne fa satira, non aveva un rapporto del tutto conflittuale, tanto è vero che ha abitato a lungo proprio in quella Città de La Cava. Che a suo dire “apprezzava, rispettava e considerava come una figlia proveniente dalle sue viscere”: una “confessione” che, per quanto possa anche essere ironica, esprime comunque, unita al legame di vita stessa, un forte attaccamento alla Città e, come dimostrato dai versi e dalle sue opere, anche una valida e sostanziale conoscenza di essa.
Braca, laureato a Salerno ma assiduo frequentatore della corte aragonese e degli ambienti più colti (conoscendo persone come Caracciolo e basile), ha inteso prima di tutto fare letteratura, come dimostra il fatto che ha composto anche opere di altro genere, come le Egloghe di stampo virgiliano, dove manifesta uno spirito bucolico “brachianamente agrodolce”. E comunque anche qui non dimentica il richiamo a questa nostra città, che evidentemente gli stava fissa nella mente, pur con tutti i suoi difetti. Da una parte egli confronta la palude culturale cavota con la vivacità dell’ambiente napoletano, ma dall’altra non manca di esaltare la potenziale bellezza di vita offerta da La Cava, realizzata soprattutto nel passato (la madre dei lodatori del tempo andato è sempre incinta…). E in altri momenti parla addirittura di Arcadia cavota: per un poeta del tempo, impregnato di virgilianesimo, l’Arcadia rappresentava pur sempre una forma di Eden…
Nelle stesse farse, dove pur beffeggia, ora con stiletto ora con cazzotti, la “goffaggine cavota” (vedi la Farsa de La Maestra o Il maestro di schola, o anche la rappresentazione del mercato nel Sautabanco, oppure nella celebre Recevuta de lo Imperatore, con l’attesa fremente e orgogliosamente presuntuosa dei Cavoti per una “visita” che poi di fatto non ci fu), Braca non manca di citare se stesso e il fatto che forse per queste prese in giro egli sarà bastonato. E non dimentichiamo che egli nel Processo dà addirittura voce ai suoi denigratori, con una sorta di autoironia che è degna di un grande intellettuale come egli in effetti fu. Un intellettuale che non può e non deve essere ridotto solo ad un beffeggiante autore di farse, perché ha scritto di tanto altro, compreso di filosofia, come si ricava dall’indice del suo manoscritto. Un intellettuale che, parlando di una Città nobilissima come era allora La Cava (non dimentichiamo neppure questo), è stato pur capace, come sostiene Lamberti, “di conferire carattere letterario ad un genere di satira in cui i protagonisti sono le maschere degli abitanti de La Cava”.
È una dignità da riconoscere e da rivalutare, quella del Braca scrittore e della Farsa cavajola come genere. E Lamberti ha collocato un solido mattone per tale operazione. Un mattone importante e significativo, anche perché, a fronte di un tempo di linguaggio globalizzato e globalizzante ed in un ambiente critico in cui tante volte il culto dell’Italofonia a scapito delle lingue dialettali è stato eccessivo e debordante, non si perde occasione di rivalutare quelle lingue territoriali che hanno una storia ed un’identità da preservare. Lo ha fatto l’Unesco con il napoletano riconosciuto come lingua e patrimonio immateriale dell’umanità (cosa molto buona e molto giusta…), lo hanno fatto tanti operatori culturali andando a ricercare nel settoriale e ripescando proprio le farse cavajole. Queste, non dimentichiamolo, a fine Novecento sono state portate più volte in scena, con attori del calibro di Mario Scarpetta, di Antonio e Maurizio Casagrande, di Marina Pagano. E a Cava, a parte un’edizione particolarmente originale della Festa di Monte Castello, ci hanno pensato figure del calibro di Anna Maria Morgera, di Francesco Senatore e della splendida Compagnia dell’Arte Tempra ( alias Temprart) di Clara Santacroce e Renata Fusco, che proprio di recente hanno messo in scena più volte la Recevuta de lo Imperatore, con contaminazioni di altre farse cavajole.
Insomma, è una pagina della nostra storia, che in certi momenti potrebbe diventare quasi una copertina, essendo in esse Cava una sorta di “ombelico del mondo”. A quell’ombelico corrispondeva un corpo che, al di là delle piccole goffaggini, sprizzava energia da tutte le parti. Un’energia che ci servirebbe tanto ancora oggi …
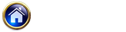

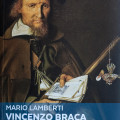

Commenti non possibili