“In nome del figlio”, secondo spettacolo dell’Autunno teatrale di Arte Tempra
Un’epopea della maternità in nome della donna.
Ombre danzanti di mani, di braccia, di corpi lentamente si stringono al centro, accompagnate da una musica avvolgente e dolcemente intensa, fino a creare un unico corpo, come di un albero ricco di rami e di frutti. Quelle ombre idealmente prenderanno corpo e anima per diventare madri inquiete, madri gioiose, madri disperate, madri egoiste, mogli amate e amanti, figlie amanti ma forse poco amate, donne in lotta col mondo. Comunque, donne. Donne che raccontano se stesse e raccontano la donna.
E sono state due ore di spettacolare emozione quelle offerte dalla magnifica squadra di attrici del Gruppo teatrale “Arte Tempra”, nella seconda pièce della Rassegna 2017-2018, “In nome del figlio”.
Giuliana Carbone, Brunella Piucci, Luciana Polacco, Manuela Pannullo, Lella Zarrella, Martina Cicco, Antonietta Calvanese, Maria Carla Ciacio, Carolina Avagliano, Danila Budetta, dirette a mano ferma da Clara Santacroce con il suo comunicativo espressionismo e con le sue classiche distoniche armonie, grazie anche alla bellissima atmosfera scenografica creata da Renata Fusco, ci hanno regalato uno degli spettacoli di maggiore respiro e coinvolgimento emozionale della pur ricca storia ventennale dell’Arte Tempra. Tanti frammenti d’autore e d’autrice (da Oriana Fallaci a Erri De luca, da Gibran a Franca Rame, dalla Jodi Picoult a Jacopone…) per creare un’epopea “universale” della maternità, forma e figura di un’epopea della donna in quanto tale.
Le interpreti, prima che con le parole, hanno comunicato e parlato col corpo, con gli sguardi, con le increspature della voce, con i movimenti e le espressioni corali, il che ha colorato e chiarito la forza dei contenuti, tutti ad alto tasso di intensità.
Il cammino prefigurato dalla tessitrice Clara ha un profondo respiro culturale ed umano.
Dopo la formazione del già citato “albero della donna”, il primo frutto è l’accettazione in chiaroscuro della maternità dalla Lettera ad un bambino mai nato della Fallaci: quel bambino che alla madre (una Lella Zarrella convincente nella sua inquietudine) appare come una goccia di vita scappata dal nulla , generando una paura che bagna il volto e i pensieri… eppure quella goccia diverrà mare dolente nel suo cuore. La stessa maternità poi viene accettata e vissuta con gioia, ma la madre è pur sempre e solo una “signorina”, per cui la sua felicità va in contrasto con le ciniche reazioni dei maschi che la circondano e la invitano all’aborto: in questa nuova veste la protagonista” cambia volto, assumendo quello di Manuela Pannullo, incisiva e ironica nel raccontare questo scontro tra ottusità emotiva ed emozione del cuore.
Da qui si creano due fili rossi lunghi tutto lo spettacolo, all’interno dei quali si intrecciano altre storie significative. Il principale è il filo della maternità di Miriam, rimasta incinta come per una folata di vento, fuori dal matrimonio e non del suo promesso Joseph, e come tale passibile di punizione per adulterio. Ma Joseph, per amore, l’accoglie, la protegge, la sposa e la porta lontano a partorire l’amato bambino, che, se per la madre basta che esista, anche se avrà una vita anonima, vita anonima invece non avrà, perché quel bambino è Joshua- Gesù, il cui corpo martoriato sulla croce proprio Miriam-Maria dovrà abbracciare, con strazianti grida di dolore. E dalla giovane gravidanza di Giuliana Carbone-Maria, dotata però della grazia-forza di saper affrontare il mondo, al tragico lamento di Brunella Piucci-Maria sotto la croce, grazie alle parole poetiche di De Luca e Jacopone ed alla consolidata bravura delle interpreti, con annesso physique du rôle, il filo si dipana a frammenti sempre più incalzanti, coinvolgenti, emozionati ed emozionanti. Fino allo svangante finale, con le mani disperate di Maria tese verse in controluce verso l’alto, mentre sullo schermo affiora la moderna pietà di una madre migrante sulla spiaggia tesa verso il corpo del figlioletto appena spirato.
L’altro filo rosso è una proposta veramente intrigante, ispirata al romanzo dell’inglese Jodi Picoult “La custode di mia sorella”, da cui fu tratto anche un famoso film di John Cassavetes. La vicenda è incentrata sulla figura di Anna Fitgerald, programmata “geneticamente” per poter creare una fucina di “pezzi di ricambio” per la sorella Kate, gravemente malata di leucemia e bisognosa di continue operazioni. Il monologo, elaborato dalla sedicenne Martina Cicco con una maturità ed una misura ben superiori agli slanci dei suoi sedici anni, arriva al suo acme quando ad Anna viene chiesto dalla madre di offrire un rene e lei non solo si rifiuta, ma denuncia la famiglia.
E qui, anche attraverso un drammatico incontro-abbraccio-scontro- con la madre (la cui ambivalenza di affetto e prevaricazione ben traspare dalla recitazione di Antonietta Calvanese), viene a galla l’umanità del testo, che permette di vedere il mondo da più angolazioni, da cui si capisce che esistono gesti buoni e cattiverie, ma non persone in assoluto buone e cattive, perché ognuno ha le sue caverne rispettabili e umanamente comprensibili, in cui soffiano venti in tutte le direzioni. Proprio per questo, il romanzo originario ci propone la vicenda proprio da tutte le angolazioni (Anna, Kate, La madre) e, in un efficacissimo colpo di scena, ci fa capire che la custode vera non è Anna, ma proprio la malata Kate, che cerca di proteggere Anna al punto da suggerire lei la denuncia. Poi, alla fine, sempre nel romanzo, proprio Anna morirà in un incidente e il suo rene servirà a salvare la sorella…
Come stimolo e come intensità, non sono state da meno le storie intermedie.
Il suadente e giusto invito di Kalil Gibran, Il profeta, a tutti i genitori di lasciare liberi i propri figli, perché “sono solo archi che lanciano le frecce “i nostri figli non sono i nostri figli ma figli della vita”…
E la mamma migrante che nella sua disperazione di naufraga, efficacemente resa da Danila Budetta, cerca di rassicurare il figlio Farid con la favola del bambino che diventa grande, ma non potrà evitare il risucchio nel cuore nero del mare, per una morte che evoca la terribile immagine-icona di quel bambino migrante morto sulla battigia,
… E la giovane ragazzina dell’Est europeo (dolce e dolente nella bella interpretazione di Carolina Avagliano) che diventa madre per effetto della violenza reiterata di un uomo, ma conserva un disperato amore per il bambino e con lui compie il gesto estremo “di pesciolino nel mare”, ribellandosi alle pressioni della società e di chi la giudica semplicemente una puttana considerandola “inidonea” alla maternità.
E poi, lo straordinario monologo autobiografico di Franca Rame, vittima di uno stupro disgustosamente violento e “politico”, in cui Luciana Polacco, in posizione supina e inarcata, con i muscoli tesi fino allo spasimo, è riuscita a liberare dai precordi del cuore tutto l’orrore di “quella storia” e degli stupri e delle violenze di sempre contro le donne…
Alla fine, davanti al dolore ed alle braccia alzate di Maria, il cerchio del cammino si chiude, con la riformazione dell’albero della donna, della maternità, della vita. Della vita. Ma proprio in nome della sacralità della vita stessa, il cerchio non si può chiudere. Donna è amore di andare avanti…
Per tutto questo, il saluto finale è stato fatto con il volto serio, fissato in una maschera di pensoso dolore. Nessun sorriso, nessuna parola aggiuntiva. Solo l’invito silenzioso di portarsi a casa tutte quelle storie e di guardarsi dentro e intorno, per un empatico “sentire” dalla parte della donna… e magari diventare goccia di un mare futuro in cui le cui acque siano fatte di rispetto e di amore. “In nome dei figli”, ma anche del nostro essere umano… e cercando una buona volta di essere umani …
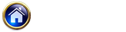













Commenti non possibili