CAVA DE’ TIRRENI (SA). Fascinoso e suggestivo il “Ritorno a Itaca” del Gruppo “Arte Tempra”.
Ma … stagione tarpata. E ora siamo noi ad aspettare il “ritorno ad Itaca”.
Le evocazioni del titolo, la forza dei personaggi e delle idee, le morbide e spettacolari suggestioni sceniche, il filo potente di una cultura giovane di duemilacinquecento anni fa che ancora oggi parla e insegna. Eccole, le belle coordinate di Ritorno a Itaca, quello che doveva essere solo il terzo spettacolo della stagione teatrale di Arte Tempra e che invece, salvo miracoli difficilmente prevedibili, ne rimarrà come l’agrodolce canto del cigno, datato febbraio 2020 presso l’Auditorium “De Filippis” di Cava de’ Tirreni.
Le coordinate di cui sopra non sono una somma, ma un prodotto. Sono elementi fortemente collegati tra loro, grazie anche alla regia e alla sceneggiatura funzionali e “ricche di anima” di Renata Fusco e Clara Santacroce.
Itaca nel mito antico è l’isola di Ulisse, della sua speranza e del suo ritorno a casa; nella cultura moderna, per dirla con il grande Costantino Kavafis, è il pensiero costante, la ragione e la meta del bel viaggio di ognuno di noi, è il luogo che ci attende “ricchi dei tesori accumulati per strada”. Ricchezze e tesori tutt’altro che materiali, ma carichi del senso stesso che nel cammino ha assunto la nostra esistenza. Perciò Itaca siamo noi, così come Ulisse è l’uomo nella sua odissea e nelle sue esplorazioni esistenziali.
Il “ritorno ad Itaca” dello spettacolo è perciò una specie di “richiamo della foresta”, è la voce delle radici specifiche di tutta la nostra civiltà e nello stesso tempo l’epopea universale della condizione umana e sociale. In questa chiave abbiamo particolarmente apprezzato il lungo e coraggioso “corridoio” iniziale, prefigurazione del “salotto” centrale: parole al minimo, movimenti lenti e solenni, una plastica scena di ondeggianti veli ora composti ora scomposti, immagini in dissolvenza e sovrapposizione della Grecia classica e di quella moderna, musiche elleniche del presente provenienti da lontano e proiettate lontano l’accenno di un pallone che in tutto lo spettacolo passerà tra le mani e forse attraverso i tempi, illuminate cromie oscillanti tra il bianco della purezza di un “paese avido di innocenza”, il rosso delle ataviche passioni di sempre, l’azzurro fiammeggiante di un mare primattore che tanto parla e tanto ha raccontato.
Dal “corridoio” al salotto il passo è stato breve e logico. E ci siamo trovati di fronte a quelle grandi figure della tragedia greca che rappresentano il paradigma della storia di sempre.
Giustamente, la prima è stata Antigone (una forte e determinata Danila Budetta), colei che affrontò la condanna a morte secondo le leggi degli uomini pur di effettuare la giusta, ma vietata sepoltura del fratello Polinice, che aveva aggredito da nemico la natia Tebe, dove era stato generato dall’amore incestuoso di Edipo e Giocasta. Da quel tempo lontano e dopo che Sofocle l’ha immortalata, Antigone è il simbolo non solo della ribellione giusta contro il potere ingiusto e/o “autodeificante” (qui impersonato dallo stentoreo Creonte di Carmine Squitieri), ma anche della donna che lotta per i diritti suoi e per la dignità della persona. È il simbolo della capacità di non avere paura di aver coraggio, quella paura che aveva frenato la sorella Ismene (una efficacemente “fragile” Martina Cicco) e che frena intere masse e milioni di singoli, è il grido dei valori assoluti, delle leggi divine (tra cui la sacralità dei defunti) contro la relatività di quelle umane e “politiche”.
È il potere del segno che si contrappone al segno del potere. E, ci sia consentito, per noi cavesi è anche qualcosa in più, per la presenza nella nostra storia di quella particolare Antigone che è stata Mamma Lucia, che a suo tempo ha rischiato la vita e la reputazione ed ha donato energie e patrimonio pur di restituire alle famiglie i corpi di oltre seicento soldati tedeschi, nemici ma “bell’ ‘i mamma”.
E come non considerare universale la figura e il dramma di Medea, che, abbandonata da Giasone (eroe antieroe nell’interpretazione di Francesco Donnarumma) dopo che ha rinunciato a tutto per aiutarlo a recuperare il vello d’oro, si vendica facendo morire la principessa che egli intende sposare e poi “gli” uccide i figli davanti agli occhi, vivendo lei stessa il dramma di moglie tradita e madre assassina. Un mostro? Non sarebbe stata una delle donne più evocate dalla letteratura e dal teatro….
Innanzitutto, e tale è apparsa anche nell’intensa e come sempre convincente interpretazione di Giuliana Carbone, in linea con la visione euripidea, pur rimanendo in ragione del suo sesso un “ambiguo malanno”, è comunque una donna “usata e gettata”, ferita profondamente nei suoi sentimenti, nel suo orgoglio e nella sua dignità, per cui diventa l’immagine vivente di quanto e come il male generi male, di come chi è oppresso possa poi passare nella schiera degli oppressori. E poi, è una straniera… e come tale considerata facilmente emarginabile…
E che dire di Ecuba, incarnata da Brunella Piucci come una statuaria e maestosa regina del dolore, dopo essere stata sovrana di un mondo? E di Andromaca (la dolente e appassionata Vivian Apicella), moglie amata dell’eroe Ettore e madre del piccolo e dolce Astianatte, scivolata nell’abisso della schiavitù e trafitta dalla perdita, pur se eroica, del marito, e dalla svangante uccisione del figlio? E di Cassandra (un’incisiva Carolina Avagliano), principessa e triste profetessa di sventure, un tempo desiderata da Apollo e ora destinata a vivere “alle ginocchia di Agamennone”? Sono loro, le euripidee Troiane piangenti sulle rovine fumanti della loro patria e in procinto di vivere ore tremende da profughe e da schiave. Sono il simbolo eterno dei popoli oppressi e smembrati, privati di tutto, tranne che della memoria e della disperazione del ricordo e della nostalgia. Nei secoli, non saranno le arroganze dei Greci vincitori a seminare valori, ma la lotta patriottica di Ettore e del “sangue per la patria perduto”, il dolore di chi ha versato tutte le lacrime della storia. La regia di Renata Fusco e Clara Santacroce ha ben messo a fuoco questo dramma individuale e collettivo, seme di libertà nell’immaginario futuro, ora giocando coi veli, ora formando i grappoli di donne ora smembrandoli, ora accentuando il ruolo nodale del coro, sempre concentrando l’attenzione sulla disperazione dei volti e le grida di dolore che da essi esplodevano,
A tutto questo aggiungiamo la consueta qualità degli altri interpreti e del gruppo, come sempre affiatato nei movimenti e nei tempi delle “coreografie parlanti” di Renata Fusco: oltre a quelli già citati, Antonietta Calvanese, Luca Capaldo, Lucrezia Macri, Simona Pagano, Manuela Pannullo, Gian Maria Salerno, Alessia Trezza, Giulia Tramice, Lella Zarrella. A sostanzioso corredo, ricordiamo gli inserimenti suggestivi e appropriati delle poesie e dei testi di autori moderni, da Kavafis a Seferis, da Fostieris a Vrettakos a Patrikios, i cammei di versi e parole greche, le musiche ariose e appropriate, e avremomo il quadro dell’ennesimo “respiro pieno” del teatro, della cultura e del linguaggio offerto da questo campo fecondo che è stabilmente l’Arte Tempra.
E si spiegano gli applausi intensi e compiaciuti che ancora una volta hanno gratificato questo lavoro. L’Arte Tempra è sempre bello sapere che c’è. E speriamo che ci sarà ancora al più presto, nel nebuloso dopoguerra post-Corona prossimo venturo. Intanto anche noi ora vaghiamo nel mare, e tutti noi abbiamo la stessa Itaca da sognare, nell’attesa del Grande Ritorno …
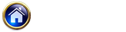




















Commenti non possibili