Aulica testimonianza esistenziale in SEGN E ARTAJ SEGNI E RITAGLI di Maria Lenti.
 Ho tra le mani l’ultimo raffinato testo di Maria Lenti: Segn e Artaj Segni e Ritagli, Pref. di Gualtiero De Santi, puntoacapo 2024. Un volume di poesie bilingue dialetto urbinese /italiano. Urge cosi per il non disattento lettore una doppia lettura. Ogni dialetto diverso dal nostro “spaventa”, spavento dato dalla forma a noi sconosciuta (e spesso visceralmente rifiutata), ma come afferma Andrè Martinet, (e ritorno così a miei ventun anni, alla mia Tesi di Laurea sul grande linguista), ogni lingua è funzionale alla comunicazione e pertanto non ci si può basare sulla forma, ma essenzialmente bisogna ricercarne il contenuto. E ritengo che questo principio debba approdare ancor di più nell’uso del dialetto. Esso, infatti, se si allontana dalla parlata dialettale spontanea, dalla genuina cultura indigena, ovvero se diventa solo strumento in contrapposizione alla cultura dominante, diventa distintivo settario ininfluente al processo culturale dell’intero Paese, se non d’ostacolo.
Ho tra le mani l’ultimo raffinato testo di Maria Lenti: Segn e Artaj Segni e Ritagli, Pref. di Gualtiero De Santi, puntoacapo 2024. Un volume di poesie bilingue dialetto urbinese /italiano. Urge cosi per il non disattento lettore una doppia lettura. Ogni dialetto diverso dal nostro “spaventa”, spavento dato dalla forma a noi sconosciuta (e spesso visceralmente rifiutata), ma come afferma Andrè Martinet, (e ritorno così a miei ventun anni, alla mia Tesi di Laurea sul grande linguista), ogni lingua è funzionale alla comunicazione e pertanto non ci si può basare sulla forma, ma essenzialmente bisogna ricercarne il contenuto. E ritengo che questo principio debba approdare ancor di più nell’uso del dialetto. Esso, infatti, se si allontana dalla parlata dialettale spontanea, dalla genuina cultura indigena, ovvero se diventa solo strumento in contrapposizione alla cultura dominante, diventa distintivo settario ininfluente al processo culturale dell’intero Paese, se non d’ostacolo.
Prezioso quindi il suo uso e prezioso giunge questo doppio lavoro lirico del poeta Lenti che s’inserisce in quel filone di grandi poeti che hanno usato “ lo strumento del dialetto” come comunicazione: basterebbe solo qualche nome come Pasolini o come Zanzotto che auspicava: “Il linguaggio ritrovi la sua integrità primigenia e a ciò, oltre ai linguaggi colti, contribuisce il dialetto” mettendo così al centro della sua poetica l’indimenticato amato uso del petel, particolare linguaggio a due, che le mamme trevigiane usavano per coccolare i loro piccoli. Quasi un SOS per una lingua italiana oggi sempre più “ anglofila”, confusa, approssimativa, a volte perfino gratuita!
E allora eccoci con Lenti in questo itinerario lessicale poetico. Al centro di questo lavoro è la Parola, antica, popolare, aulica, sofferente, financo insoddisfatta vincitrice, ma sempre viva, reale, vera a dispetto di tutti e perfino magica o velata a volte anche di malinconica ironia. Vis poiein che dall’interno si proietta all’esterno, ora in accettazione, rifiuto, analisi dell’esistente, spesso in costante contrasto pure nelle presunte accettazioni. E’ il mondo di dentro che vuole e deve uscire, malinconico, dubbioso ma pur sempre imperioso. Non è la realtà che detta la vita, e il nostro “sguardo” che dà vita e prende da esso la vita, qualunque essa sia. Esemplare la lirica d’apertura “Du’ parole /Due parole “ . “Rideranno per l’insistenza/ a mettere due parole in croce”. Chi può ridere, o peggio irridere, della fatica del disegno di “mettere due parole in croce”? E’ come chiedere di non respirare, di far tacere il ritmo del cuore: per il poeta, come si diceva, la parola è vita. Mai di nulla il poeta è sicuro, non detta certezze, è solo in un eterno dualismo con se stesso con il tutto che lo circonda “ su me sull’intorno/per un’incisione/che dica quel che non va/e quel che dovrebbe essere “ e la sua un’eterna ricerca vitale “ mi piace la mia giornata” dove ostacoli non mancano “ con il sole a piombo o senza”. E non c’è altra attesa che non coincida con la fine “finché non si spezza il filo” . E quella testimonianza montaliana del filo che “s’addipana” nell’’affannosa ricerca del “varco” .
E ben venga, poi, la filastrocca giaculatoria” Tacchina tacchina, vieni da me” (rivisitata da “Lucciola, lucciola”) nel lamento per il mancato illusorio ritorno dell’urbinata “Galnaccia galnaccia” che si lega in aulico pathos ben maggiore per echi da chanson de geste per l’amato eroe lontano e mai più ritornato.
Ed ecco ancora la cantilena da antiche credenze popolari come in “Non si sa mai” , a tema le castagne matte dell’ippocastano “ mettne una tle sacocc o tla cartella/per tiena distanti la tossa el rafredor la febra/ l’in fluenza/ ogni malanno “ /credenza cui non credo”. Ma una castagna matta finisce “(“dentro la mano chiusa nella tasca/per tutto l’inverno/live come un’eco/ non si sa mai) ”. Sublime il verso “lieve come un’eco”. Il poeta Lenti sa che non è vero che guarisce “ogni malanno” ma nel suo gesto “ dentro la mano chiusa”, è racchiusa la voce, anzi l’eco, che imperterrita eterna e lega tutti noi al nostro passato remoto o prossimo; è un’eco muta che non solo non può andar dispersa ma che ci deve accompagnare come presenza reale e costante da tramandare.
Non solo quindi il rimando al dialetto come recupero letterario e sociale ma come linfa vitale. Ricordiamo cosa diceva Tullio De Mauro: ” I dialetti sono preziosi. Sono come la campagna e la città è la lingua nazionale. Per avere condizioni di vita moderna e agiata che offre la città, non si deve, per questo, distruggere il verde e la campagna che restano elementi preziosi anche per la vita cittadina”. Insomma “coltivare “ i dialetti come cosa viva e insostituibile. Non posso non citare, in fine, il distico “ San Valentino” che trovo di una forza straordinaria “- L’amore s’è nascosto, a piangere/ – Dimmi dove, ché vado a consolarlo”. Versi che richiamano magiche atmosfere Tagoriane come da “Stray Birds”, oggetto di una mia riscrittura poetica di alcuni anni or sono. Ecco che nel giorno della festa di San Valentino, l’amore invece di essere gioioso e festante, declina tutto il suo dolore, non ha nulla da festeggiare, ma questa sua sofferenza non è palese “s’è nascosto, a piangere”. Pronto, in suo soccorso arriva il poeta che si offre di consolarlo seppure denunciando di ignorare il luogo dove esso si nasconde, forse, oramai nel cuore degli uomini induriti da tanto quotidiano dolore.
Antonio Donadio
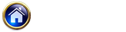
Commenti non possibili